Alessandro Manzoni- Sul Romanticismo.Lettera al marchese Cesare D’Azeglio
I.
[1823]
Pregiatissimo Signore,
Le debbo grazie singolari per l’onore ch’Ella mi ha fatto di ripublicare quel mio inno, per le copie che me ne ha voluto trasmettere, e singolarissime poi per la lettera con la quale si è degnata accompagnarle. La lunghezza nella quale prevedo che trascorrerà questa risposta, Le sarà una prova, forse troppo convincente, del conto ch’io faccio, e della lettera, e della occasione per essa offertami di trattenermi con Lei.
Il componimento che me l’ha procurata, non era da prima mia intenzione di publicarlo, se non quando avessi potuto dargli qualche altri compagni; ma per servire al desiderio di alcuni amici, senza dar fuori al pubblico sì poca cosa, ne feci tirare un picciolissimo numero di copie. Non ne avendo alcuna, qui in villa, mi do invece l’onore di trasmetterle quell’una che mi trovo avere di due versioni latine che ne furon fatte; lodate entrambe dagli intendenti, per un diverso genere di merito. Eccole tolto lo scrupolo d’essere stato il primo a publicarlo: ma in verità, se la cosa fosse stata così, Ella non dovrebbe sentire altro scrupolo che di aver troppo solleticato il mio amor proprio, col farsi editore d’un mio componimento.
Le rendo pur grazie dell’avermi Ella creduto degno di sentire il nobile ed affettuoso pensiero, col quale Ella ha cercato di raddolcire l’afflizione del suo amico, che Dio ha visitato con severa misericordia: e se mi verrà il caso, le protesto che mi varrò di quel pensiero, come di cosa mia; poichè Ella me ne ha così gentilmente messo a parte.
E grazie pure (è forza ch’io ripeta questa espressione, poich’Ella me ne moltiplica le occasioni) grazie pure Le debbo ch’Ella m’abbia avvertito dello svarione topografico incorso nel viaggio del diacono ravennate. Al leggere il luogo della sua pregiatissima che tocca questo punto, io andava pensando come mai potessi esser caduto in quell’equivoco, quando ho immaginate, e cercate di descrivere le posizioni quali Ella le indica, e quali sono in fatti. Mi sono poi avveduto che l’equivoco sta in quelle parole: alla destra piegai verso aquilone : ed è nato dall’aver io, scrivendole, dimenticato affatto che in quel momento io rappresentava il viaggiatore tornante indietro dalle Chiuse verso l’Italia. Non badai a quella sua situazione accidentale, e lo immaginai rivolto con la persona verso il campo di Carlomagno, dove, per dir così, guardavano i suoi disegni. Se Adelchi avrà vita per una seconda edizione, io approfitterò del cortese suo avviso: così si fosse Ella compiaciuta di correggervi errori di maggior momento.
Ma in quel troppo indulgente giudizio dei miei pochi e piccioli lavori drammatici, Ella ha pur lasciato trasparire, se non una opinione poco favorevole, almeno un presagio di poca durata al sistema di poesia, secondo il quale quei lavori sono concepiti. Che ha Ella fatto? Con due righe di modesta dubitazione, se n’è tirate addosso Dio sa quante, Dio sa quante pagine, di cicalamento affermativo. Nella sua gentilissima lettera Ella ha parlato d’una causa per la quale io tengo, d’una parte ch’io seguo: e questa parte è quel sistema letterario a cui fu dato il nome di romantico. Ma questa parola è adoperata a così vari sensi, ch’io provo un vero bisogno d’esporle o d’accennarle almeno quello ch’io vi intendo, perchè troppo m’importa il suo giudizio. Oltre la condizione comune a tutti i vocaboli destinati a rappresentare una serie d’idee e di giudizii, d’essere diversamente intesi, o almeno non identicamente dalle diverse persone, questo povero romanticismo ha anche significati espressamente distinti, e in alcune parti opposti, in Francia, in Germania, in Inghilterra; in Italia poi, s’io non m’inganno, nei varii stati, anzi nelle varie città: senza contar quelle, dove non sarà mai stato proferito, o qualche volta per caso, come un termine di magia. In Milano dove se n’è parlato più, e più a lungo che altrove, la parola romanticismo, se qui pure non m’inganno, è stata adoperata a rappresentare un complesso d’idee più ragionevole, più ordinato, più generale che nessun altro al quale sia stata applicata la stessa denominazione. Potrei rimettermi a qualche scritto dove quelle idee sono ridotte a pochi capi principali, molto meglio ch’io non sappia fare: ma il mio scopo (per quanto io ne senta la picciolezza) è pure di esporle, o a dir meglio di sottoporle il mio modo particolare di vedere in quella quistione. Dovrò quindi toccare di nuovo alcuni punti massimi di quelle idee, per soggiungere alcune mie opinioni su quelli: dico alcuni ed alcune, perchè sento troppo bene quanto mi convenga di ristringermi, e di fare almeno un abuso moderato della sua sofferenza.
Il sistema romantico, del quale Le parlo come di cosa viva, giacchè certe idee ragionevoli, le grida possono bensì stordirle, ma non ammazzarle, offre naturalmente due grandi divisioni: la parte negativa, e la positiva.
La prima tende principalmente ad escludere: la mitologia; l’imitazione dei classici, propriamente detta; le regole fondate su fatti speciali e non su principii generali, su l’autorità dei retori e non sul ragionamento; e specialmente quella delle due unità drammatiche.
Quanto alla mitologia, i romantici hanno detto che era cosa assurda parlare del falso riconosciuto come si parla del vero, per la sola ragione che altri altre volte l’hanno tenuto per vero; cosa fredda introdurre nella poesia ciò che non entra nelle idee, ciò che non richiama alcuna memoria, alcun sentimento della vita reale; cosa noiosa ricantare sempre questo freddo e questo falso; cosa ridicola ricantarlo con serietà, con aria d’importanza, con movimenti finti ed artefatti di persuasione, di maraviglia, di venerazione, etc. I classicisti hanno opposto che, togliendo la mitologia, si spogliava la poesia d’immagini, le si toglieva la vita: i romantici, in risposta, hanno citata tutta quella gran parte di poesia moderna che è fondata su la religione, o dalla quale almeno la mitologia è esclusa, e che pure passa per vivissima poesia anche presso i classicisti. Questi hanno replicato che la mitologia era un complesso di sapientissime allegorie: gli altri hanno risposto che, se sotto quelle stolte fandonie v’era realmente un senso importante e ragionevole, bisognava esprimer questo immediatamente; che se altri, in tempi lontani, avevano stimato bene di dire una cosa per farne intendere un’altra, avranno forse avute ragioni che non si vedono nel caso nostro; come non si vede perchè questo scambio d’idee immaginato una volta debba divenire e rimanere come una dottrina, una convenzione perpetua. I classicisti hanno detto ancora che la mitologia non era altrimenti noiosa; e hanno addotto in prova il sentimento di tanti secoli, e degli uomini più colti di quei secoli, i quali si sono deliziati nella favola: gli altri hanno risposto, che la mitologia, diffusa perpetuamente nelle opere degli scrittori greci e latini, compenetrata con esse, veniva naturalmente a partecipare della bellezza, della coltura, e della novità di quelle, per gl’ingegni che, al risorgimento delle lettere cercavano quelle opere, con curiosità, con entusiasmo, e con una riverenza superstiziosa; come era troppo naturale. Un tale interesse per la mitologia, comunicato dagli uomini studiosi di professione alla massa della gente colta, trasfuso nelle prime idee dei giovanetti, coi primi studii, mantenuto dalla lettura di quelle opere, ha dovuto sopravvivere alla sua cagione principale, l’abitudine conservandogli quella vita che la novità gli aveva data. Ma, concludevano i romantici, certe assurdità possono bensì prolungarsi per molte generazioni; ma farsi eterne non mai: il momento della caduta viene una volta; e per la mitologia è venuto. Non è venuto, rispondevano i classicisti, e in prova adducevano il sentimento loro, cioè di molti, pei quali la mitologia era tuttavia interessante. Al che replicavano ancora i romantici che quando un errore deve cadere, una abitudine cessare, v’ha sempre di quegli che vogliono difendere il primo, mantenere la seconda, di quegli che a tutta forza gli sostengono su l’orlo del precipizio, e non gli abbandonano, se non quando il peso è divenuto superiore alle forze loro: e fra questi, per una fatalità singolare, o a dir meglio, per una prova della debolezza dell’ingegno umano v’ha sempre degli uomini che ne hanno assai. E voi, dicevano, voi siete questi ultimi difensori della mitologia; e la prova che siete gli ultimi è per noi nel modo che tenete in difenderla; nella variazione perpetua dei vostri argomenti, nel replicare che fate quei che sono confutati, senza distruggere le confutazioni: due grandi caratteri delle cause che stanno per esser perdute.
Tale, se mal non mi ricordo, giacchè scrivo di memoria, e senza aver sott’occhio alcun documento della discussione, tale è la somma delle cose scritte e dette pro’ e contra la mitologia.
Per la mia parte, le ragioni dei romantici, nella sfera in cui entrambe le parti avevano posta la quistione, mi parevano allora, e mi pajono più che mai concludentissime. La mitologia non è morta certamente; ma io la credo ferita mortalmente; tengo per fermo che Giove, Marte e Venere faranno la fine che hanno fatta Arlecchino, Brighella e Pantalone, che pure avevano molti, e feroci, e taluni ingegnosi sostenitori: anche allora si disse che, con l’escludere quegli spettabili personaggi, si toglieva la vita alla commedia, che si perdeva una gloria particolare all’Italia (dove si ripone talvolta la gloria!); anche allora si udirono lamentazioni patetiche, che ora ci fanno maravigliare non senza un po’ di riso, quando le troviamo negli scritti di quel tempo. Allo stesso modo io tengo per fermo che si parlerà generalmente fra non molto della mitologia, e dei dolori che nacquero dal vederla combattuta; tengo per fermo che si parlerà dell’epoca mitologica della poesia moderna, come noi ora parliamo del gusto del seicento, anzi con tanto più di maraviglia, quanto l’uso della favola è più essenzialmente assurdo, che non i concettini, più importantemente assurdo, che non i bisticci.
Ma la ragione per la quale principalmente io ritengo detestabile l’uso della mitologia, e utile quel sistema che tende ad escluderla, non la direi certamente a chichessia, per non provocare delle risa che precederebbero e impedirebbero ogni spiegazione; ma non lascerò di sottoporla a Lei, che, se la trovasse insussistente, saprebbe addirizzarmi senza ridere. Tale ragione per me è, che l’uso della favola è vera idolatria. Ella sa molto meglio di me che questa non consisteva soltanto nella credenza di alcuni fatti naturali o soprannaturali; i fatti non ne erano che la parte storica; ma la parte morale, e molto della parte dogmatica (se mi è lecito applicare ad un tal caso una parola associata alle idee più sante) questa parte tanto essenziale era fondata nell’amore, nel rispetto, nel desiderio delle cose terrene, delle passioni, dei piaceri, portato fino all’adorazione, nella fede in quelle cose, come se fossero il fine, come se potessero dare la felicità, salvare. L’idolatria in questo senso può sussistere anche senza la credenza alla parte storica, senza il culto; può sussistere pur troppo anche negli intelletti persuasi della vera fede: dico l’idolatria; e non temo di abusare del vocabolo, quando San Paolo lo ha applicato espressamente all’avarizia, e in altri termini ha dato la stessa idea dell’affetto ai piaceri del gusto.
Ora, che è la mitologia conservata nella poesia, se non questa idolatria? E dove trovarne la dichiarazione e la prova più espressa, che negli argomenti sempre adoperati a raccomandarla? La mitologia, si è sempre detto, serve a rappresentare al vivo, a rendere interessanti le passioni, le qualità morali, anzi le virtù. E come fa ella questo la mitologia? Entrando, per quanto è possibile, nelle idee degli uomini che riconoscevano un dio in quelle cose, usando del linguaggio di quelli, tentando di fingere una credenza a ciò che essi credevano, ritenendo insomma della idolatria tutto ciò che è compatibile con la falsità riconosciuta di essa. Così l’effetto generale della mitologia non può essere che di trasportarci alle idee di quei tempi in cui il Maestro non era venuto, di quegli uomini che non ne avevano la predizione e il desiderio, di farci parlar tuttavia come se Egli non avesse insegnato, di mantenere i simboli, le espressioni, le formole dei sentimenti che Egli ha inteso distruggere, di farci lasciar da canto i giudizii ch’Egli ci ha dati delle cose, il linguaggio che è la vera espressione di quei giudizii, per ritenere le idee e i giudizii del mondo pagano. Nè può dirsi che il linguaggio mitologico, adoperato come è nella poesia, sia indifferente alle idee, e non si trasfonda in quelle che l’intelletto tiene risolutamente e avvertitamente. E perchè dunque si farebbe uso di quel linguaggio, se non fosse per affezione a ciò che esso esprime? se non fosse per produrre un assentimento, una simpatia? a che altro fine si scrive e si parla? E volendo pure ammettere che quel linguaggio sia indifferente, senza effetto, che fare allora del grande argomento dei propugnatori della mitologia, che la vogliono appunto per l’effetto che essa può fare? Sia dunque benedetta la guerra che le si è fatta e che le si fa; e possa diventare testo di prescrizione generale quel verso
Vate, ah scorda gli Achei, scorda le fole
dettato in una particolare occasione da una illustre sua amica, la quale fu dei pochissimi che col fatto antivennero le teorie, cercando, e trovando spesso così splendidamente il bello poetico, non in quelle trite apparenze, nè in quelle formole convenute, che la ragione non intende o smentisce, e delle quali la prosa si vergognerebbe; ma nell’ultimo vero, in cui l’intelletto riposa.
Insieme con la mitologia, vollero i romantici escludere l’imitazione dei classici, propriamente detta. Aggiungo questa modificazione, per determinare l’idea loro, la quale non fu mai, come parve che molti volessero intendere, che non si debba né studiare i classici, né trovar mai in essi una norma, un esercizio, un addestramento allo scrivere. Se ho bene intesi gli scritti dei romantici, e i discorsi di alcuni di loro, nessuno d’essi non sognò mai una cosa simile. Sapevano essi troppo bene (e chi l’ignora?) che l’osservare in noi l’impressione prodotta dalla parola altrui c’insegna, o per dir meglio ci rende più abili a produrre negli altri impressioni consimili; che l’osservare l’andamento, i trovati, gli svolgimenti dell’ingegno altrui è un lume al nostro, che ancor quando l’ingegno non ponga direttamente questo studio nella lettura, ne resta senza avvedersene, nutrito e raffinato; che molte idee, molte immagini che esso approva e gusta gli sono scala per arrivare ad altre, talvolta lontanissime in apparenza; che in somma per imparare a scrivere bisogna leggere, come ascoltare per imparare a discorrere; e che questa scuola è allora più profittevole quando si fa su gli scritti d’uomini di molto ingegno e di molto studio, quali appunto erano fra gli scrittori che ci rimangono dell’antichità quegli che specialmente sono denominati classici. Quello che combattevano, e che avrebbero voluto sbandire è il sistema d’imitazione, che consiste nell’adottare e nel tentare di riprodurre il concetto generale, il punto di vista, se oso dirlo, dei classici; il sistema che consiste nel ritenere in ciascun genere d’invenzione il modulo che essi hanno adoperato, i caratteri che essi v’hanno posti, la disposizione e il rapporto delle diverse parti, l’ordine e il progresso dei fatti etc. Questo sistema d’imitazione, del quale ho appena toccati alcuni punti, questo sistema fondato su la supposizione a priori che i classici abbiano trovati tuti i generi d’invenzione, e il tipo di ciascuno, esiste dal risorgimento delle lettere: forse non è stato mai ridotto in teoria perfetta, ma è stato ed è tuttavia applicato in mille casi, sottinteso in mille decisioni, è diffuso in tutta la letteratura. Basti osservare un solo genere di scritti, le apologie letterarie: quasi tutti coloro che hanno perduto il tempo a difendere i loro componimenti contra coloro che avevano perduto il tempo a censurarli, quasi tutti hanno allegati gli esempii e l’autorità dei classici, come la giustificazione più evidente, e più definitiva. Non è stato ridotto in teoria: e questa appunto è forse la fatica più gravosa e la meno osservata di quegli che vogliono combattere idee false comunemente ricevute, il dover pigliarle qua e là, comporle, ridurle come in un corpo, mettere in esse l’ordine di cui eglino hanno bisogno per combatterle ordinatamente. Non è stato questo sistema nè ragionato, nè provato, nè discusso seriamente; anzi a dir vero si sono sempre messe in campo e ripetute proposizioni che gli sono opposte; sempre si è gittata qualche parola di disprezzo contra l’imitazione servile, sempre si è lodata e raccomandata l’originalità; ma insieme si è sempre proposta l’imitazione. Si è insomma sempre predicato il pro e il contra, come meglio tornava al momento, senza raffrontarli mai, nè stabilire un principio generale. Questo volevano i romantici che si facesse una volta, volevano che, da litiganti di buona fede, si definisse una volta il punto della quistione, e si cercasse un principio ragionevole in quella materia; domandavano che si riconoscesse espressamente che, quantunque i classici abbiano scritte cose bellissime, pure nè essi, nè alcun altri non ha dato, nè darà mai un tipo universale, immutabile, esclusivo di perfezione poetica; quando questa frase voglia dir qualche cosa. E non solo mostrarono in astratto l’arbitrario e l’assurdo di quel sistema d’imitazione; ma cominciarono anche ad indicare in concreto molte cose evidentemente irragionevoli introdotte nella letteratura moderna col mezzo della imitazione dei classici, e che altrimenti non ci sarebbero venute.
Tale è, per citarne un solo esempio, il costume ideale, falso, e strano della poesia bucolica. Chiedevano i romantici che si facesse una attenta e sagace ricerca su tutta la parte d’idee, di forme etc. che può essersi introdotta nella letteratura moderna per quel mezzo; che tutto ciò che non v’era entrato che per questa via, venisse escluso, escluso per principio, come in parte è già avvenuto in fatto. Poichè molti di questi modi d’imitazione, adottati per qualche tempo, sono poi stati ripudiati, o abbandonati con ragione, ma forse senza un ragionamento, e certo senza un ragionamento generale e applicabile a tutti i casi simili: come per esempio, gli schiavi plautini e terenziani tanto adoperati nelle commedie dell’Ariosto, ed esclusi dalle più moderne. Così pure i costumi e il linguaggio bucolico convenzionale pare che passi affatto di moda.(le mode letterarie sono talvolta più strane di quelle del vestire, ma non cangiano così sovente); pare che finalmente, non solo i lettori, ma anche i poeti ne sieno ristucchi. Ma invece di seguir lungo tempo una moda per imitazione, e di abbandonarla poi per sazietà, non sarebbe meglio esaminare una volta con la ragione ciò che è da scegliere e ciò è che da lasciare? Così pare che pensassero i romantici.
All’esame poi del principio e dei fatti aggiungevano molti argomenti generali. Che gli antichi, o almeno i più lodati di essi, sono stati appunto eccellenti, perchè cercavano la perfezione nel soggetto stesso che trattavano, e non nel rassomigliare a chi ne aveva trattati di simili; e che quindi per imitarli nel senso più ragionevole e più degno del vocabolo, bisognava appunto non cercare d’imitarli nell’altro senso servile. Che molte cose dei classici erano piaciute perchè avevano trovata negli intelletti una disposizione a gustarle, nata da circostanze, da idee, da usi particolari che più non sono. Che fra i moderni stessi, i più vantati son quelli che non imitarono, ma crearono; o per parlare un po’ più ragionevolmente, seppero scoprire ed esprimere i caratteri speciali, originali degli argomenti che presero a trattare; e che v’è un po’ di contraddizione nel dire: prendete a modelli quegli scrittori che furono sommi, perchè non presero alcun modello. Etc. etc.
A dire il vero, non mi ricordo che cosa si rispondesse a tutti questi ragionamenti, nè se vi si rispondesse direttamente. So bene d’avere udito che si parlava assai d’un bello perpetuo: ma io non ho mai compreso che cosa significassero quelle due parole, nè a dir vero, ho voluto stillarmi il cervello, per comprenderlo; perchè supponeva che se avessero un senso preciso, quegli che le ripetevano, lo avrebbero finalmente dichiarato, come fanno tutti coloro che concepiscono chiaramente un’idea, e bramano di farla ricevere; massimamente se quella idea è combattuta; perchè allora il desiderio di persuadere fa che essi studiino tutti i modi di trasmettere alle menti altrui ciò che persuade la loro. Qualche tempo dopo la cessazione di quelle spiacevoli dispute, un mio amico mi fece grazia di comunicarmi in manoscritto un suo Trattato sul Bello; opera che, se non m’inganno, riunisce due pregi singolari: d’essere affatto nuova, e di contenere la ricapitolazione di tutto ciò che è stato detto d’importante sul soggetto; e dopo la publicazione della quale, io son d’avviso che nessun uomo d’ingegno piglierà più a trattare la questione che vi è risoluta; e molti vi troveranno invece l’indicazione di nuove quistioni da trattarsi. Fra le altre idee che ho acquistate da quella lettura, v’ho anche trovato ch’io non aveva avuto il torto a non intendere e a non cercare il senso di quelle due parole; perchè non ne hanno; non esprimono un giudizio che l’analisi renda più lucido, e l’osservazione dei fatti più evidente, ma uno di quei giudizii nati, per dir così, prima sul labbro che nella mente, e che svaniscono a misura che uno li contempla con attenzione.
Mi ricordo però molto bene d’un carico che si dava a coloro che avevano messi in campo i ragionamenti sopra indicati intorno all’imitazione: che essi vilipendessero i classici, deridessero il giudizio di tanti secoli, pretendessero doversi ciò che ne era stato l’oggetto, gittar via come anticaglie di nessun pregio. I romantici, se io ho ben letto, rigettarono sempre un tal carico, e negarono questi sentimenti che venivan loro apposti, e sostennero che non ve n’era traccia nelle loro espressioni, nè tampoco nelle conseguenze legittime e ragionevoli di queste. Anzi, per mostrarlo più evidentemente, cercarono, se ben mi ricordo, tutte le occasioni di lodare i classici ragionatamente, e di notare in essi dei pregi che non erano stati indicati dai loro più fervidi ammiratori. Taluno perfino lodò quelle bellezze, in bellissimi versi; ne riprodusse alcune, traducendole, o facendole sue; e con una tale riuscita, che chi pretendesse d’avere pei classici una ammirazione più sentita della sua, mostrerebbe una grande stima non solo di questi, ma di se medesimo.
Per me, le confesso che non solo ho per irrefragabili tutti quei ragionamenti contra l’imitazione, ma che, nel caso speciale della imitazione dei classici, tengo dei sentimenti molto più arditi, molto più irriverenti. Mi guarderei bene dal pubblicarli, ma li sottopongo a Lei con la stessa libertà che ho fatto gli altri.
La parte morale dei classici è essenzialmente falsa: false idee di vizio e di virtù, idee false, incerte, esagerate, contraddittorie, difettive dei beni e dei mali, della vita e della morte, di doveri e di speranze, di gloria e di sapienza; falsi giudizii dei fatti, falsi consigli; e ciò che non è falso in tutto, manca però di quella prima ed ultima ragione che è stata una grande sciagura il non aver conosciuta, ma dalla quale è stoltezza il prescindere scientemente e volontariamente. Ora la parte morale, come è la più importante nelle cose letterarie, così vi tiene maggior luogo, v’è più diffusa che non appaja al primo sguardo. Per la ragione sopraddetta, io non potrei mai, adottando il linguaggio comune, chiamar miei maestri quegli che si sono ingannati, che m’ingannerebbero in una tale e in una tanta parte del loro insegnamento; e desidero ardentemente che invece di proporli, come si fa da tanto tempo, alla imitazione dei giovanetti, si chiamino una volta all’esame da qualche uomo maturo: dico un esame intento, risoluto, insistente, che costringa l’attenzione dei molti su questo argomento. E certo, non mi limiterei ad accennare su di ciò confidenzialmente, e superficialmente poche idee a Lei, che non ne ha bisogno, se non mi sentissi troppo lontano da quella autorità, e da quella potenza di parole, senza la quale si guastano le migliori cause, si prolunga la vita, e si aumenta l’attività dell’errore, che si vorrebbe distruggere. Frattanto, e finchè arrivi l’uomo che intenda a questa buona e bella opera, io desidero almeno che, o per l’influenza di quegli scrittori che in diversi tempi hanno portato sui classici un più libero giudizio, o per riflessione, o foss’anche per incostanza, si perda di quella venerazione per essi così profonda, così solenne, così assoluta, così magistrale, che previene ed impedisce ogni esercizio del ragionamento. Desidero che, anche parlando dei classici, si adoperi, massimamente coi giovanetti quel linguaggio più misurato, più riposato, che adoperano per le altre cose umane tutti coloro che ne osservano, con qualche attenzione, i diversi aspetti. Desidero che, per gli argomenti dei romantici, e per qualunque altra via ragionevole, si screditi sempre più quel sistema d’imitazione, pel quale si attingono e si trasfondono tanti sentimenti falsi, e si perpetuano nella letteratura, e per mezzo della letteratura, nella vita giudizii irragionevoli e appassionati.
Le ragioni del sistema romantico per escludere la mitologia e l’imitazione, sono come Ella ha certamente veduto, molto congeneri. E pur molto congeneri alle une e alle altre sono le ragioni per isbandire le regole arbitrarie, e specialmente quella delle due unità drammatiche. Di queste ultime non le parlerò: forse ne ho anche troppo ciarlato in istampa; e non so s’io debba dolermi o rallegrarmi di non avere una copia da offrirle d’una mia lettera pubblicata in Parigi su questo argomento; una lettera, alla lunghezza della quale spero tuttavia che non aggiugnerà questa, di cui a dir vero comincio a vergognarmi. Ma la bontà ch’Ella m’ha dimostrata, mi fa animo; e proseguo.
Intorno alle regole in generale, ecco quali furono, se la memoria non mi falla, le principali proposizioni romantiche. Ogni regola, per esser ricevuta da uomini, debbe avere la sua ragione nella natura della mente umana. Dal fatto speciale che un tale scrittor classico, in un tal genere, abbia ottenuto l’intento, toccata la perfezione, se si vuole, con tali mezzi, non se ne può dedurre che quei mezzi debbano pigliarsi per norma universale, se non quando si dimostri che essi sieno applicabili, anzi necessarii a tutti i casi, come a quel caso; e ciò per legge dell’intelletto umano. Ora, molti di quei mezzi, di quei modi messi in opera dai classici furono suggeriti ad essi dalla natura particolare del loro soggetto, erano appropriati a quello, individuali per così dire; e l’averli trovati a quella opportunità è un merito dello scrittore, uno dei caratteri che lo rende originale, ma non una ragione per farne una legge comune; anzi è una ragione per non farnela. Di più, anche nella scelta dei mezzi, i classici possono avere errato; perchè no? e in questi casi, invece di cercare nel fatto loro una regola da seguire, bisogna osservarvi un fallo da evitarsi. A voler dunque approfittare con ragione della esperienza, e prendere dal fatto un lume pel da farsi, si sarebbe dovuto scernere nei classici ciò che è di ragione perpetua, ciò che è di opportunità speciale, ciò che è vizioso. Se questo discernimento fosse stato tentato ed eseguito da filosofi, converrebbe tener molto conto delle loro fatiche, senza però ricevere ciecamente le loro decisioni. Ma, in iscambio, questa provincia è stata invasa, corsa, signoreggiata quasi sempre da retori estranei affatto agli studii su l’intelletto umano; questi hanno dal fatto, inteso come essi potevano, dedotte le leggi che hanno volute; hanno ignorate, o ripudiate le poche ricerche dei filosofi in quella materia, o se ne sono impadroniti, le hanno commentate a loro modo, travisate, o anche talvolta hanno messo sotto il nome e l’autorità di quelli le loro povere e strane prevenzioni. Ricevere senza esame, senza richiami, leggi di tali, e così create, è cosa troppo fuori di ragione. E quale infatti, aggiungevano, è l’effetto più naturale del dominio di queste regole? Di distrarre l’ingegno inventore dalla contemplazione del soggetto, dalla ricerca dei caratteri proprii ed organici di quello, per rivolgerlo e legarlo alla ricerca e all’adempimento di alcune condizioni talvolta affatto estranee al soggetto, e quindi d’impedimento a ben trattarlo. E un tale effetto non è egli troppo manifesto? Queste regole non sono elleno state per più un inciampo a quegli che tutto il mondo chiama scrittori di genio, e un’arme in mano di quegli che tutto il mondo chiama pedanti? E ogni volta che i primi vollero francarsi di quell’inciampo, ogni volta che meditando sul loro soggetto, e trovandosi a certi punti dove, per non istorpiarlo, era forza di violare le regole, essi le hanno violate, che ne è avvenuto? I secondi gli attendevano al varco; e senza pensare, nè voler pensare, nè volere intendere le ragioni di quelle che essi chiamavano violazioni; senza provare, nè saper pure che ad essi incumbeva di provare che l’obbedire alla regola sarebbe stato un mezzo per trattar meglio quel soggetto, gridarono ad ogni volta, contra la licenza, contra l’arbitrio, contra l’ignoranza dello scrittore. Ora, poichè ciò che ha dato sempre tanta forza ai pedanti contra gli scrittori d’ingegno è appunto questo rispetto implicito per le regole giuste e false; perchè, dicevano i romantici, lasceremo noi sussistere una tal confusione? perchè lasceremo sussistere un mezzo per tormentare gli uomini d’ingegno? Non sono essi sempre stati tormentati più del bisogno?
Dall’altra parte, proseguivano, non è egli vero che, passato un certo tempo, quella stessa violazione delle regole che era stato un capo d’accusa per molti scrittori, divenne per la loro memoria un soggetto di lode? Che ciò che si chiamava sregolatezza ebbe poi nome di originalità? E una delle lodi che noi italiani in ispecie diamo ai poeti che più siamo in uso di lodare, non è ella forse dell’aver eglino abbandonate le norme comuni, dell’essersi resi superiori a quelle, dell’avere scelta una via non tracciata, non preveduta, nella quale la critica non aveva ancor posti i suoi termini, perchè non la conosceva; e il genio solo doveva scoprirla? Se essi dunque hanno fatto così bene, prescindendo dalle regole, perché ripeteremo sempre che le regole sono la condizione essenziale del far bene? Alla ragione che i romantici cavavano da questo fatto, mi ricordo che si dava generalmente una risposta non nuova, ma molto singolare: ho detto generalmente, perchè io non intendo qui di esporle se non ciò che mi sembra essere stato il sentimento più comune degli avversarii del sistema romantico: se mi sovvenisse di qualche argomento particolare ad un libro o ad una persona, non ne farei parola: confutare altrui dietro le spalle, in una lettera confidenziale non mi pare cortesia: in pubblico poi, e a viso aperto, mi guarderei bene dal farlo, per non provocare dispute, delle quali il solo pensiero mi contrista. Si ripeteva dunque quella ricantata sentenza: che molte cose sono lecite ai grandi scrittori, ma ad essi soli; che essi possono dispensarsi da certe regole; ma che in ciò la loro pratica non è un esempio per gli altri. Le confesso che non ho mai potuto comprendere la forza dell’argomento che pare esser rinchiuso in questa sentenza. Cercando la cagione per cui quei grandi scrittori hanno ottenuto l’effetto, colla violazione delle regole, m’è sempre paruto che la cagione fosse questa: che essi, veggendo nel soggetto una forma sua propria, che non avrebbe potuto entrare nella stampa delle regole, hanno gittata via la stampa, hanno svolta la forma naturale del soggetto, e così ne hanno cavato il più e il meglio che esso poteva dare al loro ingegno. Il lecito, l’illecito, la dispensa, non veggo che ci abbiano a fare; mi sembrano metafore che in questo caso non hanno un senso al mondo. Ora, quella ragione non è per nulla particolare ai grandi ingegni; è universalissima, è della natura stessa della cosa, esprime il mezzo, col quale grandi e piccioli, ognuno secondo la sua misura, può fare il meglio possibile. Oh, i mediocri non giungeranno mai a scoprire in un argomento quella forma splendida, originale, grandiosa, che appare ai grandi ingegni. Sia col nome del cielo, non vi giungeranno; ma di che ajuto saranno ad essi le regole? O le sono ragionevoli; e in questo caso i grandi scrittori non debbono dispensarsene, perchè sarebbe privarsi d’un ajuto a trovare e ad esprimere più potentemente quella forma. O le sono irragionevoli; e debbono dispensarsene anche i mediocri, perchè elle non potranno fare altro che impacciarli di più, allontanarli dalla verità del concetto, e mettere la storpiatura, dove senza di esse non sarebbe stato che imperfezione. Onde quanto più io penso a questa doppia misura di regole, obbligatorie per molti e per alcuni no, tanto più essa mi pare fuor di proposito. Ed è se non m’inganno stata trovata per uscire d’impaccio: quando ci si mostra contraddizione tra due proposizioni che noi affermiamo, e quando pure non vogliamo ne compararle, nè abbandonarne nessuna, nè sappiamo come farle andar d’accordo, ne inventiamo una terza, la quale mette la pace fra le parole se non fra le idee; non serve al ragionamento, ma serve a rispondere, che infine è poi quello che più preme. Ma se anche una tale strana distinzione si volesse ammettere, che farne poi in pratica, come applicarla nel fatto? L’uomo che, nell’atto del comporre, si trova combattuto fra la regola e il suo sentimento, dovrà egli proporsi questo curioso problema: sono io, o non sono un grand’uomo? E come scioglierlo poi? – Oh, si fidi al suo genio, se ne ha; e lasci dire. – Si fidi! Veramente l’esperienza può ispirar molta fiducia: e come possono dire, si fidi, quegli appunto che vogliono tenere in vigore e in attività tutti quei mezzi che sono sempre stati adoperati a togliere la fiducia agli scrittori distinti, e che l’hanno realmente tolta a molti di essi? Lasci dire! mi pare che invece di consigliare quei pochi infelici che portano la croce del genio, a non curare le nostre parole, sarebbe tempo che cominciassimo noi a pesarle un po’ più.
Ma io, dimenticando che parlo con un giudice, mi son lasciato andare un momento a garrire colla parte avversaria. Scusi di grazia questa scappata; e mi scusi anche del rimettermi che faccio in via, ad infastidirla ancor qualche tempo.
Alle altre proposizioni messe in campo dai romantici contra le regole arbitrarie, non mi ricordo, a dir vero, se qualche cosa si rispondesse; nè veggio che cosa si possa rispondere. Si diceva bene da molti che il fine di quelle proposizioni era di togliere le regole tutte, anzi di sbandire ogni regola dalle cose letterarie, di autorizzare, di promovere tutte le stravaganze, di riporre il bello nel disordinato. Che vuol Ella? A questo mondo è sempre stato usanza di intendere e di rispondere a questo modo.
Prima di abbandonare il discorso delle regole, mi permetta ch’io Le sottoponga una osservazione, che non mi sovviene di aver trovata proposta da altri. Ed è, che il soggetto di una quistione, che dura da tanto tempo, non è stato mai definito con precisione: la parola regole su la quale si rivolge la disputa, non ha mai avuto un senso determinato. Supponiamo un uomo che sentisse per la prima volta parlare di questa discussione intorno alle regole; egli dovrebbe certamente supporre che elle fossero determinate in formole precise, descritte in un bel codice conosciuto e riconosciuto da tutti quegli che le ammettono; tante, nè più nè meno, tali, e non altrimenti. Perchè la prima condizione per far ricevere altrui una legge, è di fargliela conoscere. Ora Ella sa se la cosa sia così. E se, per fare un’altra supposizione, uno di quegli che ricusano questo dominio indefinito delle regole, dicesse ad uno di quegli che lo propugnano: sono convinto; questa parola regole ha un non so che, che mi soggioga l’intelletto; mi rendo, e per darvi una prova della mia docilità, vi faccio una proposizione, la più larga che in nessuna disputa sia stata fatta giammai. Pronunziate ad una ad una le formole di queste regole adottate, come voi dite, da tutti i savii, e ad ognuna io risponderò accettando. Certo costui, con tanta sommissione apparente, farebbe all’altro una brutta burla, lo porrebbe in uno strano impiccio.
Son ben lontano dal credere di avere espressa una idea compiuta della parte negativa del sistema romantico. Molte cose saranno sfuggite alla mia osservazione, quando la quistione si dibatteva, molte di poi dalla memoria, e molte ne ho ommesse a bello studio; o perchè non potevano così naturalmente venire sotto quei pochi capi che ho scelti a discorrere, o anche, se non ad effetto, almeno ad intento di brevità. Pure oso credere che anche il poco che io ho qui affoltato di quel sistema, basti a farne sentire il nesso e l’importanza, a farvi scorgere la vasta e conseguente applicazione d’un principio a molti fatti della letteratura, ed una forse ancor più vasta e feconda applicabilità a tutti i fatti della letteratura stessa.
Dovrei ora passare alla parte positiva, e spicciarmi; ma non posso trattenermi di parlarle d’una obiezione, o per dir meglio, d’una critica che si faceva al complesso delle idee che ho toccate fin qui. Si diceva che tutte quelle idee, tutti quei richiami, tutte quelle proposte di riforma letteraria erano cose vecchie, ricantate, sparse in cento libri. Che questa fosse una critica oziosa agli ingegni, non una obiezione al sistema, è cosa troppo manifesta. La quistione era se molte idee fossero vere o false; che c’entrava ch’elle fosser nuove o vecchie? Riconosciuta la verità, o dimostrata la falsità delle idee, anche l’altra ricerca poteva essere utile alla storia delle cognizioni umane; ma anteporre questa ricerca, farne il soggetto principale della quistione, era un cangiarla, per non risolverla. Ma oltre l’essere quella critica inopportuna, le confesso che mi pare anche affatto ingiusta.
Molte di queste idee, tutte queste idee, dicevano alcuni oppositori, sono state già messe in campo; la tale è del tale scrittore, morto da un secolo; la tal’altra del tal altro. Non parliamo di quelle che erano affatto nuove, e non furono così poche; le opposizioni stesse ne provocarono assai. Ma il nesso delle antiche, ma la relazione scoperta e indicata fra di esse, ma la luce e la forza reciproca, le modificazioni, le estensioni, le restrizioni che venivano a tutte dal solo fatto di classificarle sotto ad un principio, il sistema in somma, da chi era stato immaginato, da chi proposto, da chi ragionato mai? Ma, dalle ricchezze intellettuali sparse, dal deposito confuso delle cognizioni umane, raccogliere pensieri staccati e accidentali, verità più tosto sentite che tenute, accennate più tosto che dimostrate; subordinarle ad una verità più generale che riveli fra esse una associazione non avvertita in prima; cangiare i presentimenti di molti uomini d’ingegno in dimostrazioni, e le dubitazioni in scienza; togliere a molte idee l’incertezza e l’esagerazione; sceverare quel misto di vero e di falso che le faceva rigettare in tutto da molti, e ricevere in tutto da altri, con un entusiasmo irragionevole; collocarle con altre che servono ad esse di limite e di prova ad un tempo, non è questa la lode d’un buon sistema? Ed è ella una lode tanto facile, e tanto spesso meritata? E chi mai ha desiderato o immaginato un sistema che non contenesse fuor che idee tutte nuove? Sarebbe esso ragionevole, intelligibile, possibile?
Del resto non è qui da vedersi una ingiustizia particolare: l’accusa di plagio è stata fatta sempre agli scrittori che hanno detto il più di cose nuove: sempre s’è andato a frugare nei libri antecedenti per trovare che il tal principio era stato già immaginato e insegnato etc. sempre s’è detto ch’ella era la centesima volta che quelle idee venivano proposte. E che avrebbero potuto rispondere gli scrittori? Tal sia di voi, che siete stati sordi le novantanove. Tal sia di voi che avendo in tanti libri tutte queste idee, non ne tenevate conto, e pensavate sempre come se non fossero mai state proposte. Ora noi vi abbiamo costretti ad avvertirle; quando non avessimo fatto altro, questo almeno è qualche cosa di nuovo.
Se alcuno volesse provare che i pregi da me accennati poco sopra, ed altri simili, non si trovano nel sistema romantico, mi pare che ascolterei le sue prove con molta curiosità, e con una docilità spassionata: ma ciò non è, ch’io sappia, stato fatto, nè tentato. Intanto io non posso a meno di non ravvisarvi quei pregi; e mi accade spesso leggendo opere letterarie, precettive o polemiche, anteriori al sistema romantico, di abbattermi in idee molto ragionevoli, ma indipendenti dalla dottrina generale del libro, idee volanti per così dire, le quali nel sistema romantico sono collocate razionalmente, e vi sono divenute stabili, e feconde. Similmente nei libri di scrittori ingegnosi, ma paradossai di professione, mi accade spesso di trovare di quelle opinioni speciose e vacillanti, che da una parte hanno l’aria d’una verità triviale, e dall’altra d’un errore strano, e di riflettere con piacere che quelle opinioni trasportate nel sistema romantico, vi sono legate e temperate in modo che il vero ne è serbato, ed appare più manifesto ed importante; e il falso, lo strano, ne è naturalmente separato ed escluso. Le sottoporrei esempii e prove di queste osservazioni, se non temessi di troppo trattenerla, e se non pensassi che, quando Ella le creda degne d’esser verificate, troverà nella sua memoria più abbondante e più opportuna materia, ch’io non saprei somministrargliene.
Per tutto ciò la parte negativa è, al parer mio, la più notabile del sistema romantico, almeno del trovato ed esposto fino ad ora.
Il positivo non è di lunga mano nè così preciso, nè così diretto, nè sopra tutto così esteso. Oltre quella condizione generale dell’intelletto umano, che lo fa esser più celere nel distruggere che nell’edificare, la natura particolare del sistema romantico doveva produrre questo effetto. Proponendosi quel sistema di escludere tutte le norme che non sieno veramente generali, perpetue, ragionevoli per ogni lato, viene a renderne più scarso il numero, o almeno più difficile e più lenta la scelta. Un’altra cagione fu la breve durata della discussione, e il carattere che essa prese fino dal suo principio. Come il negativo era naturalmente il primo soggetto da trattarsi, così esso occupò quasi interamente quel poco tempo. La discussione poi prese pur troppo un certo colore di scherno, come per lo più accade: ora in tutte le quistioni trattate schernevolmente v’è più vantaggio nell’attaccare che nel difendere: quindi i romantici furono naturalmente portati a diffondersi e ad insistere più nella parte negativa, nella quale, a dir vero, avevano troppo bel giuoco; e quanto al positivo furono portati a tenersi a principii generalissimi, che danno meno presa a cavillazioni, ad esclamazioni, a parodie. Non potè per questo il sistema romantico evitare la derisione; ma almeno quegli che vollero deriderlo, furono costretti ad inventarne essi uno, e ad apporlo a chi non l’aveva mai nè proposto né sognato: metodo tanto screditato, ma d’una riuscita quasi infallibile; e che probabilmente si dismetterà alla fine del mondo.
Se la disputa avesse continuato, o per meglio dire, se invece d’una disputa vi fosse stata una investigazione comune, dall’escludere si sarebbe passato al proporre, anzi in questo si sarebbe fissata la maggiore intenzione degli ingegni. E allora, io tengo per certo che le opinioni sarebbero state tanto più varie quanto più abbondanti, e che molti ingegni, movendo da un centro comune, si sarebbero però avviati per tanti raggi diversi, allontanandosi anche talvolta l’uno dall’altro sempre più a misura che si sarebbero avanzati: tale è la condizione delle ricerche intellettuali intraprese da molti. Ma il sistema romantico non potè giungere, o per dir meglio, non è ancor giunto a questo periodo. E ciò non ostante, un grande rimprovero che veniva fatto ai suoi sostenitori, era che egli non s’intendevano nemmeno fra loro: cominciassero, si diceva, ad accordarsi perfettamente nelle idee, prima di proporle altrui come verità. Rimprovero, al quale non posso tuttavia pensare senza maraviglia. In regola generale, quegli che così parlavano, chiedevano una cosa che l’ingegno umano non ha data, nè può dar mai. Mai questa concordia perfetta di più persone in tutti i punti d’un sistema morale non ha avuto luogo: bisognerebbe ad ottenerla, che per tutti questi punti si adottassero da ciascuno altrettanti giudizii, altrettante formole uniche ed invariabili; anzi, che tanti uomini divenissero un solo, per potere, ad ogni nuovo caso, fare una identica applicazione di quei giudizii generici. V’è bene un ordine di cose, nel quale esiste una essenziale ed immutabile concordia; ma quest’ordine è unico; i suoi caratteri, le sue circostanze sono incomunicabili. Quest’ordine è la Religione: essa dà una scienza che l’intelletto non potrebbe scoprire da sè, una scienza che l’uomo non può ricevere che per rivelazione e per testimonianza; ora una sola rivelazione, inchiude una sola dottrina, e quindi produce una sola credenza. E anche in quest’ordine la concordia delle menti non è comandata che dove è sommamente ragionevole; cioè in quei punti nei quali la verità non si può sapere che per la testimonianza di cui è stata rivelata, cioè della Chiesa: non è comandata questa concordia, che al momento in cui l’unico testimonio ha parlato. Ma nelle cose umane questo testimonio non esiste, non è stata nè fatta nè promessa ad alcuno una comunicazione di scienza, una assistenza nelle decisioni: quindi i giudizii variano secondo la varietà degli ingegni, e riescono generalmente così dissimili, che a chiamare uno un sistema, non si ricerca mai il fatto impossibile che esso riunisca tutti i giudizii in una materia, ma il fatto difficile e raro, che ne riunisca molti, nei punti principali di essa.
Nel caso particolare poi del sistema romantico, il rimprovero mi pareva molto stranamente applicato. Se quegli che lo facevano, avessero voluto riandare la storia dei sistemi umani, avrebbero trovato, io credo, che pochi furono quegli che presentassero meno dissentimenti del romantico. Se avessero soltanto fatto un po’ di esame sul sistema chiamato classico, al quale essi volevano che si desse la preferenza, avrebbero tosto potuto scorgere quanto più gravi e più numerosi sieno in esso i dispareri, le incertezze, le varie applicazioni, la diversità dei principii stessi; avrebbero veduto quanto sarebbe più difficile di ridurlo a formole generali, di farne una, per dir così, confessione, che fosse comunemente ricevuta da coloro che ricevono la parola, classico. E se pur fosse loro spiaciuto di notare la cagione principale di questa differenza fra i due sistemi, che è l’essere il classico non il prodotto d’una ricerca di principii, ma un aggregato casuale di fatti convertiti in principio, avrebbero potuto osservare, e dire con ragione che la concordia de’ molti nel sistema romantico nasceva dalla scarsezza delle sue idee positive.
Ma intorno a questo poco, anzi, ch’è peggio, prima di giungervi, io son riuscito a spendere di molte ciarle. Mi studierò in compenso di esser breve, o almeno ristretto in ciò che mi resta a dirle. Ommettendo quindi i precetti o i consigli positivi proposti pei casi particolari, e con applicazione immediata; precetti e consigli, alcuni dei quali certamente potranno divenire soggetto di quistione, e che tutti insieme formano, a quel che me ne pare, un saggio molto pregevole, ma un saggio di ciò che può farsi col tempo; mi limiterò ad esporle quello che a me sembra il principio generale a cui si possano ridurre tutti i sentimenti particolari sul positivo romantico. Il principio, di necessità tanto più indeterminato quanto più esteso, mi sembra poter esser questo: Che la poesia, e la letteratura in genere debba proporsi l’utile per iscopo, il vero per soggetto, e l’interessante per mezzo. Debba per conseguenza scegliere gli argomenti, pei quali la massa dei lettori ha, o avrà a misura che diverrà più colta, una disposizione di curiosità e di affezione, nata da rapporti reali, a preferenza degli argomenti, pei quali una classe sola di lettori ha una affezione nata da abitudini scolastiche, e la moltitudine una riverenza non sentita nè ragionata, ma ricevuta ciecamente. E che in ogni argomento debba cercare di scoprire, e di esprimere il vero storico, e il vero morale; non solo come fine, ma come più ampia e perpetua sorgente del bello: giacchè e nell’uno e nell’altro ordine di cose, il falso può bensì dilettare, ma questo diletto, questo interesse è distrutto dalla cognizione del vero; è quindi temporario e accidentale. Il diletto mentale non è prodotto che dall’assentimento ad una idea; l’interesse, dalla speranza di trovare in quella idea, contemplandola, altri punti di assentimento, e di riposo: ora quando un nuovo e vivo lume ci fa scoprire in quella idea il falso, e quindi l’impossibilità che la mente vi riposi e vi si compiaccia, vi faccia scoperte, il diletto e l’interesse spariscono. Ma il vero storico e il vero morale generano pure un diletto; e questo diletto è tanto più vivo e tanto più stabile, quanto più la mente che gusta è avanzata nella cognizione del vero: questo diletto adunque debbe la poesia e la letteratura proporsi di far nascere.
Tale mi sembra, bene in astratto, com’Ella vede, l’ultimo risultato delle opinioni sul positivo romantico. Dico l’ultimo risultato, perchè, se ho ben potuto osservare il corso di quelle opinioni, da principio le più s’erano arrestate ad un punto indietro assai da questo, anzi opposto in gran parte. Escludendo con ragione dalla poesia ciò che non è fondato su una persuasione dell’intelletto, vi si ammetteva, come per la ragione dei contrarii, ciò che è universalmente creduto, vero o falso che sia, come un mezzo di fare effetto. Per questo principio si concedeva che la mitologia, intollerabile per noi, sia bella nei poeti gentili, etc. etc. Dalla idea giusta che l’assentimento o, per meglio dire un tal quale assentimento dell’intelletto, sia necessario a produrre l’interesse, si passava a supporre che basti: non si pensò su le prime, che la parola può non solo approfittare di questo assentimento, ma distruggerlo e crearne un nuovo; e che debbe farlo, o tentarlo ogni volta che quell’assentimento non sia ragionevole. Un tale errore però, (credo di poter dargli questo nome) non era nato qui; è di alcuni distinti scrittori stranieri, i quali offesi principalmente, e stomacati di quel sistema di poesia che prendeva per base il falso non creduto, sentendo vivamente che il principio dell’esser commosso è il credere, proposero che la commozione poetica si cercasse nelle cose credute; nè andarono più là, ch’io sappia. Non è da stupirsi che una tale dottrina, paragonata a quella che era stata tenuta fin allora, paresse in sul principio sapienza: ma l’averla di poi abbandonata, per giungere ad un principio più solido, mi pare un vero e non volgare progresso.
Non dissimulo, nè a Lei, che sarebbe un povero ed inutile artificio, nè a me stesso, perchè non desidero ingannarmi, quanto indeterminato, incerto e vacillante nell’applicazione, sia il senso dei vocaboli: utile, vero, interessante. E per non parlare che d’uno di essi, Ella sa meglio di me che il vero tanto lodato e tanto raccomandato nelle opere d’immaginazione, non ha mai avuto un significato preciso. Il suo ovvio e comune non può essere applicato a queste, perchè di consenso universale, vi debbe essere dell’inventato, cioè del falso. Il vero che debbe trovarvisi da per tutto, et même dans la fable, è dunque qualche cosa di diverso da ciò che si vuole esprimere ordinariamente con quella parola; o per dir meglio è qualche cosa di non ancor definito; nè il definirlo mi pare impresa molto agevole, quando pure ella sia possibile. Comunque sia, una tale incertezza non è particolare al principio che ho tentato di esporle; è comune a tutti gli altri, è antica; il sistema romantico ne ritiene meno di qualunque altro sistema letterario, perchè la parte negativa, specificando il falso, l’inutile o il dannoso, il freddo che vuole escludere, indica e circoscrive nelle idee contrarie qualche cosa di più preciso, un senso più lucido di quello che abbiano avuto finora. Del resto, in un principio così recente, non si vuol tanto guardare agli svolgimenti che possa aver già ricevuti, quanto a quelli di cui è capace. La formola che esprime quel principio è così generale, le parole di essa hanno, se non altro, un suono, un presentimento d’idee così bello e così savio, il materiale dei fatti che debbono servire agli esperimenti, è così abbondante, che è da credersi che un tale principio sia per ricevere di mano in mano svolgimenti, spiegazioni, e conferme, di cui ora non è possibile prevedere in concreto nè il numero nè l’importanza.
Tale almeno è l’opinione ch’io ho fitta nella mente, e nella quale io mi rallegro, perchè questo sistema, non solo in alcune parti, come ho accennato più sopra, ma nel suo complesso mi sembra avere una tendenza religiosa.
Questa tendenza era ella nelle intenzioni di quelli che l’hanno proposto, e di quelli che l’hanno approvato? Sarebbe leggerezza l’affermarlo di tutti; perchè in molti scritti di teorie romantiche, anzi nella maggior parte, le idee letterarie non sono espressamente subordinate alla religione. Sarebbe temerità il negarlo, anche d’un solo; perchè in nessuno di quegli scritti, almeno dei letti da me, la religione è esclusa. Non abbiamo nè i dati, nè il diritto, nè il bisogno di fare un tal giudizio: una tale intenzione, certo desiderabile, certo non indifferente, non è però necessaria per farci dare la preferenza a quel sistema. Basta che in effetto abbia la tendenza che si è detta. Ora, il sistema romantico, emancipando la letteratura dalle tradizioni etniche, disobbligandola, per così dire, da una morale voluttuosa, superba, feroce, circoscritta al tempo, e improvvida anche in questa sfera, antisociale dove è patriottica, ed egoistica quando cessa d’essere ostile, tende certamente a render meno difficile l’introdurre nella letteratura le idee e i sentimenti che dovrebbero informare ogni discorso. E dall’altra parte, proponendo, anche in termini generalissimi, il vero, l’utile, il buono, il ragionevole, concorre se non altro con le parole, che non è poco, allo scopo della religione, non la contraddice almeno, nei termini. Per quanto una tale azione d’un sistema letterario possa essere indiretta, oso pur tenermi sicuro ch’Ella non la giudicherà indifferente, Ella che senza dubbio avrà più volte osservato quanto influiscano sui sentimenti religiosi i diversi modi di trattare le scienze morali, che tutte alla fine appartengono alla religione; quantunque distinzioni e classificazioni arbitrarie possano separarnele in apparenza e in parole; Ella che avrà più volte osservato come senza parere di toccare la religione, senza nè pur nominarla, una scienza morale prenda una direzione opposta ad essa, pervenga a risultati che sono inconciliabili logicamente con gli insegnamenti di essa; e come talvolta poi, avanzando, o dirigendosi meglio nelle scoperte, essa stessa convinca d’errore quei risultati, e venga così a riavvicinarsi alla religione, senza pur nominarla, direi quasi senza avvedersene. Non so s’io m’inganni, ma mi sembra che più d’una scienza morale faccia ora questo corso felicemente retrogrado. L’economia politica, per esempio, nel secolo scorso, aveva in molti punti, adottati quasi senza opposizione, canoni opposti affatto al Vangelo; e li proponeva con tale asseveranza, con tale impero, con tali minacce di compassione sprezzante a chi esitasse nell’ammetterli, che molti deboli ricevendo questi canoni, furono persuasi che la scienza del Vangelo era corta e meschina, che i suoi precetti non avevano potuto comprendere tutto il possibile svolgimento dei rapporti sociali: molti altri, credendo di riconoscere verità puramente filosofiche, adottarono con una docilità non ragionevole dottrine opposte al Vangelo. Ed ecco che, per un progresso naturale delle scienze economiche, per un più attento e più esteso esame dei fatti, per un ragionato cangiamento di principii, altri scrittori, in questo secolo, hanno scoverta la falsità, e il fanatismo di quei canoni; e sul celibato, sul lusso, su la prosperità fondata nella rovina altrui, sur altri punti pure importantissimi, hanno stabilite dottrine conformi ai precetti ed allo spirito del Vangelo; e s’io non m’inganno, quanto più quella scienza diviene ponderata e filosofica, tanto più ella diventa cristiana. E più ch’io considero, più mi pare che il sistema romantico tenda a produrre, abbia cominciato a produrre nelle idee letterarie un cangiamento dello stesso genere.
Se dovessi scrivere questi pensieri per la stampa, mi troverei costretto di soggiunger qui tosto molte restrizioni, perchè altri non credesse o volesse credere ch’io intendo che il sistema romantico renderà spirituale tutta la letteratura, farà dei poeti tanti predicatori etc. Ma scrivendo a Lei, se diffido delle mie idee, ho almeno la soddisfazione d’esser certo ch’elle saranno prese secondo la loro misura reale; e in tante lungaggini, posso almeno risparmiarle quelle che sarebbero destinate a prevenire le false interpretazioni, e quell’affettato frantendere che molti trovano più comodo e più piccante dell’intendere.
Dopo d’averle, a dritto e a rovescio, e forse con più fiducia che discrezione, sottomesso il mio parere sur una materia toccata appena indirettamente nella sua gentilissima lettera, non so se mi rimanga ancora qualche diritto di parlare del punto ch’Ella ha accennato più espressamente: voglio dire il trionfo o la caduta probabile del sistema romantico. Ma giacchè in più luoghi di questa cicalata ho preso la libertà di proferire con molta confidenza, pronostici lieti per quel sistema, i quali a prima giunta possono parere in opposizione col fatto, non posso a meno di sottometterle anche le ragioni di quei pronostici, quali mi par di vederle nello stato reale delle cose, rimosse le prime apparenze.
Se uno straniero, il quale avesse inteso parlare dei dibattimenti che ebbero luogo qui intorno al romanticismo, venisse ora a chiedere a che punto sia una tale quistione, si può scommettere mille contr’uno, che s’udrebbe rispondere a un dipresso così: Il romanticismo! se n’è parlato qualche tempo, ma ora non se ne parla più: Solutae sunt risu fabulae. La parola stessa è dimenticata; se non che di tempo in tempo vi capiterà forse di sentire pronunziare l’epiteto romantico per qualificare una proposizione strana, un cervello bislacco, una causa spallata, che so io? una pretesa esorbitante, un mobile fuori di sesto. Ma non vi consiglierei di parlarne sul serio: sarebbe come se in mezzo ad una società alcuno venisse a chiedere se la gente si diverte tuttavia molto col kaleidoscopio. Se l’uomo che avesse udita questa risposta, fosse di quelli che sanno ricordarsi all’opportunità che una parola s’adopera per molti significati, e insistesse per sapere che cosa intenda per romanticismo il suo interlocutore, vedrebbe che intende un non so qual guazzabuglio di streghe, di spettri, un disordine sistematico, una ricerca dello stravagante, una abjura in termini del senso comune, un romanticismo insomma, che si è avuto molta ragione di rifiutare e di dimenticare, se è stato proposto da alcuno; il che io non so.
Ma se per romanticismo si vuole intendere la somma delle idee, delle quali Le ho male esposta una parte, questo, non che esser caduto, vive, prospera, si diffonde di giorno in giorno, invade a poco a poco tutte le teorie dell’estetica, i suoi risultati sono sempre più frequentemente riprodotti, applicati, posti per fondamento dei diversi giudizii. Nella pratica poi non si può non vedere una tendenza della poesia ad attingere lo scopo indicato dal romanticismo, a cogliere e a raffigurare quel genere di bello di cui le teorie romantiche hanno data una idea I astratta, fugace, ma che basta già a disgustare dell’idea che le è opposta. Un altro indizio manifesto della vita e del vigore di quel sistema, sono gli applausi dati universalmente a lavori, che ne sono l’applicazione felice. Non dovrei citare appunto un esempio che si presenta naturalmente da sè alla memoria; ma ne parlerò pel piacere che provo nel rammentare la giustizia renduta al lavoro d’un uomo, a cui mi lega un’amicizia fraterna. Quando comparve l’Ildegonda, bollivano le quistioni sul romanticismo, e non sarebbe stato gran maraviglia se l’avversione di molti alla teoria avesse prevenuto il loro giudizio contra un componimento che l’autore non dissimulava d’aver concepito secondo quella. Eppure la cosa andò ben altrimenti: le opinioni divise su la teoria furono conformi (moralmente parlando) in una specie di amore pel componimento. Ed ora, trapassato già più tempo che non ne sia generalmente concesso alle riuscite effimere, quel favore, mi pare di poter dire quell’entusiasmo è divenuto una stima, che sembra dover esser perpetua. E se un ben altro lavoro già avanzato, farà al suo apparire, che quel primo non compaja più che un saggio, oso pur credere che non potrà farlo dimenticare, e che facendolo partecipare della fama che sarà cresciuta al nome dell’autore, non gli toglierà quella che da sè ha potuto procacciarsi. In tutta la guerra del romanticismo, non è dunque morta che la parola. Cessi che a nessuno venga in mente di risuscitarla; sarebbe un rinnovare la guerra, e forse un far danno all’idea, che senza nome, vive e cresce con bastante tranquillità. E quand’anche l’idea stessa dovesse guadagnare nel rinnovamento dei contrasti, una tale vittoria non sarebbe certo desiderabile ad un tal costo: il trionfo più assoluto di qualunque teoria letteraria non vale a compensare un rancore tra due uomini, e una riga d’ingiurie.
Eccomi una volta al termine: il rimorso continuo di tanta prolissità mi ha forzato tante volte a chiederlene scusa, che le scuse stesse sono divenute allungamenti; e non oso più ripeterle. Si degni Ella di gradire in quella vece l’espressione del sincero ossequio, e della viva gratitudine che Le professo, e di accogliere il desiderio che nutro di poter quando che sia, esprimerle a voce questi sentimenti, coi quali ho l’onore di rassegnarmele
P. S. – Per non ritardare davvantaggio la risposta alla sua gentilissima lettera, lascio partir questa, quale è, sparsa di sgorbi e di cancellature. Ella me ne scuserà, ricordandosi che non si può mostrare altrui benevolenza, come Ella ha fatto con me, senza ispirargli un poco di famigliarità.
Brusuglio, presso a Milano, li 22 settembre, 1823.
Divotissimo, obbligatissimo servitore
Alessandro Manzoni
II.[1]
Questa lettera non fu scritta con l’intenzione di darla alle stampe, come appare anche da qualche luogo del contesto. Ma trovandola pubblicata da altri, l’autore, dopo averla o ritoccata o rinnovata in varie parti, ha creduto che potesse, malgrado le imperfezioni che ci sono rimaste, aver luogo in questa raccolta, come un ricordo d’un momento della letteratura italiana, momento finito oramai da un pezzo, ma che, di certo, non ha lasciate le cose come le aveva trovate, e non fu senza un qualche effetto, anche fuori d’Italia.
Le note sono state aggiunte nella presente edizione
[Chiudi]
[1871]
Pregiatissimo Signore,
Ma in quel troppo indulgente giudizio de’ miei pochi e piccoli lavori drammatici, Ella ha anche lasciato trasparire, se non un’opinione poco favorevole, o almeno un presagio di poca durata, al sistema di poesia, secondo il quale quei lavori sono concepiti. Cos’ha mai fatto? Con due righe di modesta dubitazione se n’è tirate addosso Dio sa quante, Dio sa quante pagine, di cicalamento affermativo. Nella sua gentilissima lettera Ella ha parlato d’una causa, per la quale io tengo, d’una parte, che seguo; e questa parte è quel sistema letterario, a cui fu dato il nome di romantico. Ma questa parola è applicata a così vari sensi, ch’io provo un vero bisogno d’esporle, o d’accennarle almeno quello ch’io c’intendo, perchè troppo m’importa il di Lei giudizio. Oltre la condizione comune a tutti i vocaboli destinati a rappresentare un complesso d’idee e di giudizi, quella, cioè, d’essere intesi più o meno diversamente dalle diverse persone, questo povero romanticismo ha anche de’ significati espressamente distinti, in Francia, in Germania, in Inghilterra. Una simile diversità, o una maggior confusione, regna, se non m’inganno, in quelle parti d’Italia dove se n’è parlato; giacchè credo che, in alcune, il nome stesso non sia stato proferito, se non qualche volta per caso, come un termine di magia. In Milano, dove se n’è parlato più e più a lungo che altrove, la parola romanticismo, è stata, se anche qui non m’inganno, adoprata a rappresentare un complesso d’idee più ragionevole, più ordinato, più generale, che in nessun altro luogo. Potrei rimettermi a qualche scritto, dove quelle idee sono esposte e difese molto meglio di quello ch’io sappia fare; ma, oltre lo scopo di rappresentarne un concetto complessivo, Le confesso che l’onore ch’Ella m’ha fatto di toccarmi questo tasto, m’ha data la tentazione di sottoporle un qualche mio modo particolare di considerar la questione. M’ingegnerò di ridurre e una cosa e l’altra nei termini più ristretti che mi sarà possibile, e di fare almeno un abuso moderato della sua pazienza.
Ciò che si presenta alla prima a chi si proponga di formarsi il concetto, che ho accennato di quel sistema, è la necessità di distinguere in esso due parti principali: la negativa e la positiva.
La prima tende principalmente a escludere – l’uso della mitologia – l’imitazione servile dei Classici – le regole fondate su fatti speciali, e non su princìpi generali, sull’autorità de’ retori, e non sul ragionamento, e specialmente quella delle così dette unità drammatiche, di tempo e di luogo apposte ad Aristotele.
Quanto alla mitologia, i Romantici hanno detto, che era cosa assurda parlare del falso riconosciuto, come si parla del vero, per la sola ragione, che altri, altre volte, l’hanno tenuto per vero; cosa fredda l’introdurre nella poesia ciò che non richiama alcuna memoria, alcun sentimento della vita reale; cosa noiosa il ricantare sempre questo freddo e questo falso; cosa ridicola ricantarli con serietà, con un’aria reverenziale, con delle invocazioni, si direbbe quasi ascetiche[2]
Fu una vera disgrazia (letteraria, s’intende) che nessuno di loro, o sapesse, o si rammentasse che lo stesso giudizio era stato espresso, quasi con gli stessi termini, da un uomo la di cui autorità avrebbe sbalorditi, per un momento, gli avversari. È il Tasso che parla, nel primo Discorso dell’Arte Poetica: «E quanto quel maraviglioso (se pur merita tal nome) che portan seco i Giovi e gli Apollini e gli altri numi de’ Gentili, sia non solo lontano da ogni verisimile, ma freddo ed insipido, e di nessuna virtù, ciascuno di mediocre giudicio se ne potrà facilmente avvedere, leggendo que’ poemi che sono fondati sopra la falsità dell’antica religione».
Ci vollero però due secoli e mezzo circa, perchè la maggior parte de’ poeti e de’ lettori di poeti se ne avvedessero.
[Chiudi].
I Classicisti hanno opposto che, levando la mitologia, si spogliava la poesia d’immagini, le si levava la vita. I Romantici risposero che le invenzioni mitologiche traevano, al loro tempo, dalla conformità con una credenza comune, una spontaneità, una naturalezza, che non può rivivere nelle composizioni moderne, dove stanno a pigione. E per provare che queste possono vivere (e di che vita!) senza quel mezzo, ne citavano le più lodate, nelle quali, la mitologia fa bensì capolino, ora qua, ora là, ma come di contrabbando e di fuga, e ne potrebbe esser levata, senza che ne fosse, nè sconnessa la compagine, nè scemata la bellezza del lavoro. Citavano, dico, specialmente la Divina Commedia e la Gerusalemme, nelle quali tiene una parte importante, anzi fondamentale, un maraviglioso soprannaturale, tutt’altro che il pagano; e le rime spirituali del Petrarca, e le politiche, e le rime stesse d’amore; e l’Orlando dell’Ariosto, dove invece di dei e di dee, vengono in scena maghi e fate, per non parlar d’altro. E citavano insieme varie opere straniere, che godono un’alta fama, non solo ne’ paesi dove nacquero, ma presso le persone colte di tutta l’Europa.
Un altro argomento de’ Classicisti era, che nella mitologia si trova involto un complesso di sapientissime allegorie. I Romantici rispondevano che, se, sotto quelle fandonie, c’era realmente un senso importante e ragionevole, bisognava esprimer questo immediatamente; che, se altri, in tempi lontani, avevano creduto bene di dire una cosa per farne intendere un’altra, avranno forse avute delle ragioni che non si vedono nel caso nostro, come non si vede perchè questo scambio d’idee immaginato una volta deva divenire e rimanere una dottrina, una convenzione perpetua.
Per provar poi, con de’ fatti anche loro, che la mitologia poteva benissimo piacere, anche nella poesia moderna, i Classicisti adducevano che l’uso non se n’era mai smesso fino allora. A questo i Romantici rispondevano che la mitologia, diffusa perpetuamente nelle opere degli scrittori greci e latini, compenetrata con esse, veniva naturalmente a partecipare della bellezza, della coltura, e della novità di quelle per gl’ingegni che, al risorgimento delle lettere, cercavano quelle opere con curiosità, con entusiasmo, e anche con una riverenza superstiziosa, come era troppo naturale; e che, come non era punto strano che tali attrattive avessero invogliati, fino dal principio, i poeti moderni a dare alle invenzioni mitologiche quel po’ di posto; così era non meno facile a intendersi che quella pratica, trasmessa di generazione in generazione coi primi studi, e trasformata in dottrina, non solo si sia potuta mantenere, ma, come accade delle pratiche abusive, sia andata crescendo, fino a invadere quasi tutta la poesia, e diventarne il fondamento e l’anima apparente. Ma, concludevano, certe assurdità possono bensì tirare avanti, per più o meno tempo, ma farsi eterne non mai: il momento della caduta viene una volta; e per la mitologia è venuto.
Infatti, quello stesso vigore straordinario e apparente, che aveva acquistato presso di noi, ne poteva esser riguardato come un indizio, giacchè non era l’espansione d’una forza innata della poesia, l’esercizio più vasto e più potente d’un suo mezzo naturale, ma l’applicazione sempre più esagerata d’un’aggiunta estrinseca e accidentale. E a chi volesse riflettere, doveva parere ugualmente difficile, e il supporre che quell’uso delle invenzioni mitologiche, sia prese per soggetto di componimenti poetici, sia, e molto più spesso, anzi a sazietà, introdotte in quelli, come agenti, come cause di avvenimenti, e pubblici e privati, potesse diventare una forma permanente della poesia; e l’immaginarsi quale parte più ristretta gliene potesse rimanere; in quale misura, con quale distinzione, un tale uso potesse venir mantenuto; dove si potesse trovare una ragione speciale, per la parte d’un tutto riconosciuto come irragionevole.
Tali, se mal non mi ricordo, giacchè scrivo di memoria, e senza aver sott’occhio alcun documento della discussione, erano le principali ragioni allegate pro e contro la mitologia.
Le confesso che quelle dei Romantici mi parevano allora, e mi paiono più che mai concludentissime. La mitologia non è morta certamente, ma la credo ferita mortalmente; tengo per fermo che Giove, Marte e Venere faranno la fine, che hanno fatta Arlecchino, Brighella e Pantalone, che pure avevano molti e feroci, e taluni ingegnosi sostenitori: anche allora si disse, che con l’escludere quei rispettabili personaggi si toglieva la vita alla commedia: che si perdeva una gloria particolare all’Italia (dove va qualche volta a ficcarsi la gloria!); anche allora si sentirono lamentazioni patetiche, che ora ci fanno maravigliare, non senza un po’ di riso, quando le troviamo negli scritti di quel tempo. Allo stesso modo, io tengo per fermo, che si parlerà generalmente tra non molto della mitologia, e della sua fine.
Intendo per fine, come l’intendevano i Romantici, e appariva da tutte le loro parole, il cessar d’essere una parte attiva della poesia; e questo mi fa venire in mente un’altra difficoltà che si opponeva loro, e che è un esempio curioso del vezzo tanto comune, d’allargare, cioè di trasformare delle opinioni, per combatterle più comodamente. – Stando alle vostre proposte, si diceva loro da alcuni, s’avrà a mutare una parte, non solo della poesia, ma del linguaggio comune. Non si potrà più dire: una forza erculea, un aspetto marziale, degli augùri sinceri, e una bella quantità d’altre locuzioni prettamente mitologiche. – A questo era facile il rispondere che l’istituzioni, l’usanze, l’opinioni che hanno regnato lungo tempo in una o più società, lasciano ordinariamente nelle lingue, delle tracce della loro esistenza passata, e ci sopravvivono con un senso acquistato per mezzo dell’uso, e reso independente dalla loro origine: la stessa risposta che si darebbe a chi venisse a dire: o rimettete in onore l’astrologia, o bandite dal linguaggio i vocaboli: influsso, ascendente, disastro, e altri derivati dalla stessa fonte.
Ma la ragione, per la quale io ritengo detestabile l’uso della mitologia, e utile quel sistema che tende ad escluderla, non la direi certamente a chiunque, per non provocare delle risa, che precederebbero, e impedirebbero ogni spiegazione; ma non lascerò di sottoporla a Lei, che, se la trovasse insussistente, saprebbe addirizzarmi, senza ridere. Tale ragione per me è, che fuso della favola è idolatria. Ella sa molto meglio di me, che questa non consisteva soltanto nella credenza di alcuni fatti naturali e soprannaturali: questi non erano che la parte storica; ma la parte morale era fondata nell’amore, nel rispetto, nel desiderio delle cose terrene, delle passioni, de’ piaceri portato fino all’adorazione; nella fede in quelle cose come se fossero il fine, come se potessero dare la felicità, salvare. L’idolatria in questo senso può sussistere anche senza la credenza alla parte storica, senza il culto; può sussistere pur troppo anche negli intelletti persuasi della vera Fede: dico l’idolatria, e non temo di abusare del vocabolo, quando San Paolo l’ha applicato espressamente all’avarizia, come ha anche chiamato Dio de’ golosi il ventre.
Ora cos’è la mitologia conservata nella poesia, se non questa idolatria? E qual prova più espressa se ne potrebbe desiderare, di quella che ne danno gli argomenti sempre adoprati a raccomandarla? La mitologia, si è sempre detto, serve a rappresentare al vivo, e rendere interessanti le passioni, le qualità morali, anzi le virtù. E come fa questo la mitologia? Entrando, per quanto è possibile, nelle idee degli uomini, che vedevano un dio in ognuna di quelle cose; usando del loro linguaggio; tentando di fingere una credenza a ciò, che quelli credevano; ritenendo in somma dell’idolatria tutto ciò che è compatibile con la falsità riconosciuta di essa. Così l’effetto generale della mitologia non può essere, che di trasportarci alle idee di que’ tempi in cui il Maestro non era venuto, di quegli uomini che non ne avevano né la previsione, né il desiderio; di farci parlare anche oggi, come se Egli non avesse insegnato; di mantenere i simboli, l’espressioni, le formule dei sentimenti ch’Egli ha inteso distruggere; di farci lasciar da una parte i giudizi ch’Egli ci ha dati delle cose, il linguaggio che è la vera espressione di quei giudizi, per ritenere le idee e i giudizi del mondo pagano. E non si può dire che il linguaggio mitologico, adoperato com’è nella poesia, sia indifferente alle idee, e non si trasfonda in quelle che l’intelletto tiene risolutamente e avvertitamente. E perchè dunque si farebbe uso di quel linguaggio, se non fosse per affezione a ciò che esprime? se non fosse per produrre un assentimento, una simpatia? A che altro fine si scrive e si parla? Sia dunque benedetta la guerra che gli si è fatta, e che gli si fa; e possa diventare testo di prescrizione generale quel verso:
«Vate, scorda gli Achei, scorda le fole»
dettato in una particolare occasione da una illustre di Lei amica, la quale fu de’ pochissimi, che col fatto antivennero le teorie, cercando e trovando spesso così splendidamente il bello poetico, non in quelle triste apparenze, nè in quelle formole convenute, che la ragione non intende o smentisce, e delle quali la prosa si vergognerebbe; ma nell’ultimo vero, in cui l’intelletto riposa.
Insieme con la mitologia vollero i romantici escludere l’imitazione dei classici; non già lo studio, come volle intendere la parte avversaria. Se ho bene intesi gli scritti, e i discorsi di alcuni di loro, nessuno di essi non sognò mai una cosa simile. Sapevano troppo bene (e chi l’ignora?), che l’osservare in noi l’impressione prodotta dalla parola altrui c’insegna, o per dir meglio, ci rende più abili a produrre negli altri delle impressioni consimili; che l’osservare l’andamento, i trovati, gli svolgimenti dell’ingegno altrui è un lume al nostro; che questo, ancor quando non metta direttamente un tale studio nella lettura, ne resta, senza avvedersene, nutrito e raffinato; che molte idee, molte immagini, che approva e gusta, gli sono scala per arrivare ad altre talvolta lontanissime in apparenza; che insomma per imparare a scrivere giova il leggere, e che questa scola è allora più utile, quando si fa sugli scritti d’uomini di molto ingegno e di molto studio, quali appunto erano, tra gli scrittori che ci rimangono dell’antichità, quelli che specialmente sono denominati classici.
Non cessarono quindi di protestare contro il carico che si dava loro, con quella falsissima interpretazione, di vilipendere i Classici, e di riguardare gli scritti che ce ne rimangono, come anticaglie da mettersi da parte. Anzi non trascurarono l’occasioni, non solo di lodarli in genere, ma di notare in essi dei pregi, che non erano stati indicati dai loro più fervidi ammiratori. Taluno perfino lodò quelle bellezze in molto bei versi; ne riprodusse alcune traducendole, e con una tale riuscita, che, chi pretendesse d’avere pei classici un’ammirazione più sentita della sua, mostrerebbe una grande stima non solo di questi, ma di sè medesimo[3]
Sulla poesia, Sermone di Giovanni Torti . – Trascrivo qui, e credo di poter aggiungere anche qui: in prova, la versione del discorso d’Ettore a Andromaca, nel sesto dell’Illiade.
«Ahi che il sacro Ilio, (esclama) e l’alta rocca,
E la casa di Priamo un dì cadranno!
Ma null’altra, ti giuro, il cor mi tocca
Sì acerba cura; non de’ Teucri il danno,
E non il padre, non la madre o i forti
Fratei, che molti allor sotterra andranno;
Come, o donna, il tuo pianto e l’aspre sorti
Che t’aspettan, se alcun Greco ti prenda,
E prigioniera in Argo il mar ti porti.
Tacita allora converrà che penda
Dal cenno insultator d’una straniera,
E a portar acqua e a tesser tele intenda.
E mentre indarno repugnante e fiera,
Pregno inclinando di lagrime il ciglio,
Alla fontana obbedirai l’altera;
Alcun dirà: D’Ettore a Priamo figlio
La consorte è colei; di quel che sempre
Era fra i teucri eroi primo al periglio.
Allor verrà che di più crude tempre
Dolor ti cruci, e che del tuo diletto
Più intenso desiderio il cor ti stempre.»
Disse, e le mani stese al pargoletto,
Che l’armi paventando e le criniere
Terribili, ondeggianti in sull’elmetto,
Fe’ d’un grido risposta al cavaliere,
E rifuggì della nutrice al seno
Dalle sembianze inusitate e fiere.
Parve sul volto allor quasi un baleno
Ai duo parenti il riso; Ettor si sciolse
L’elmo, e raggiante il pose in sul terreno;
Poi nelle braccia il bambinel si tolse,
Baciollo, e a Giove e agli altri Numi in questi
Detti, alzandolo al cielo, il prego volse:
«O Giove sommo, e voi tutti, o celesti,
Deh vogliate che forte, e di me degno,
Dopo di me questo mio figlio resti;
Che un dì possente abbia de’ Teucri il regno,
Che apportator di fuga e di terrore
Sia fra’ nemici, a’ suoi gloria e sostegno;
Deh fate che tornando ei vincitore,
V’abbia chi dica: Più che il padre ei vale;
E ne gioisca della madre il core.»
[Chiudi].
Quello che i romantici combattevano, è il sistema d’imitazione, che consiste nell’adottare, e nel tentare di riprodurre il concetto generale, il punto di vista dei classici, il sistema, che consiste nel ritenere in ciascun genere d’invenzione il modulo, ch’essi hanno adoprato, i caratteri che ci hanno impressi, la disposizione, e la relazione delle diverse parti; l’ordine e il progresso de’ fatti, ecc. Questo sistema d’imitazione, del quale ho appena toccati alcuni punti; questo sistema fondato sulla supposizione a priori, che i classici abbiano trovati tutti i generi d’invenzione, e il tipo di ciascheduno, esiste dal risorgimento delle lettere; forse non è stato mai ridotto in teoria perfetta, ma è stato ed è tuttavia applicato in mille casi, sottinteso in mille decisioni, e diffuso in tutta la letteratura. Basta osservare un solo genere di scritti, le apologie letterarie: quasi tutti coloro, che hanno perduto il tempo a difendere i loro componimenti contro coloro, che avevano perduto il tempo a censurarli, hanno allegati gli esempi e l’autorità dei classici, come la giustificazione più evidente, e più definitiva. Non è stato ridotto in teoria; e questa appunto è forse la fatica più gravosa e la meno osservata di quelli, che vogliono combattere idee false comunemente ricevute, il dover pigliarle qua e là, comporle, ridurle come in un corpo, metterci l’ordine, di cui hanno bisogno per combatterle ordinatamente. Non è stato questo sistema nè ragionato, nè provato, nè discusso seriamente; anzi, a dir vero, si sono sempre messe in campo e ripetute proposizioni, che gli sono opposte; sempre si è gettata qualche parola di disprezzo contro l’imitazione servile, sempre si è lodata e raccomandata l’originalità; ma insieme si è sempre proposta l’imitazione. Si è insomma sempre predicato il pro e il contro, come meglio tornava al momento, senza raffrontarli mai, nè stabilire un principio generale. Questo volevano i romantici che si facesse una volta; volevano che, da litiganti di buona fede, si definisse una volta il punto della questione, e si cercasse un principio ragionevole in quella materia; chiedevano, che si riconoscesse espressamente, che, quantunque i classici abbiano scritte cose bellissime, pure nè essi nè verun altro non ha dato, nè darà mai un tipo universale, immutabile, esclusivo di perfezione poetica. E non solo mostrarono in astratto l’arbitrario e l’assurdo di quel sistema d’imitazione, ma cominciarono anche a indicare in concreto molte cose evidentemente irragionevoli introdotte nella letteratura moderna per mezzo dell’imitazione de’ classici. E per esempio, sarebbe egli mai, senza un tal mezzo, venuto in mente a de’ poeti moderni di rappresentar de’ pastori, in quelle condizioni e con que’ costumi che si trovano nelle egloghe, o nei componimenti di simil genere, dal Sannazaro al Manara, se, prima di quello, o dopo questo, non ci furono altri poeti bucolici, o ignorati o dimenticati da me? E perchè dall’imitazione cieca e, per dir così materiale, si sdrucciola facilmente nella caricatura, avvenne, una mattina, che tutti i poeti italiani, voglio dire quelli che avevano composti, o molti, o pochi versi italiani, si trasformarono, loro medesimi (idealmente, s’intende) in tanti pastori, abitanti in una regione del Peloponneso, con de’ nomi, nè antichi, nè moderni, nè pastorali, nè altro; e in quasi tutti i loro componimenti, di qualunque genere, e su qualunque soggetto, parlavano, o ficcavano qualche cenno delle loro gregge e delle loro zampogne, de’ loro pascoli e delle loro capanne. E una tale usanza potè, non solo vivere tranquillamente per una generazione, ma tener duro contro le così frizzanti e così sensate canzonature del Baretti, e sopravvivere anche a lui.
Profittando poi, com’era facile in ogni cosa, delle contradizioni de’ loro avversari, dicevano i Romantici: Non siete voi quelli che, ne’ Classici, lodate tanto l’originalità, quell’avere ognuno di loro, un carattere proprio, spiccato e, per dir così, personale? E non è dunque in questo, cioè nel non essere imitatori, che, anche secondo voi altri, è ragionevole l’imitarli?
Le ragioni del sistema romantico, per escludere la mitologia e l’imitazione, sono, com’Ella ha certamente veduto, molto consentanee tra di loro. E consentanee ugualmente all’une, e all’altre sono le ragioni per sbandire le regole arbitrarie, e specialmente quella delle due unità drammatiche. Di queste non Le parlerò: forse ne ho anche troppo ciarlato in stampa; e non so s’io deva o dolermi o rallegrarmi di non avere una copia da offrirle d’una mia lettera pubblicata in Parigi su questo argomento [4] Lettre à M.r C… sur l’unité de temps et de lieu dans la tragédie , pag. 395 di questa edizione [Chiudi]; lettera, alla lunghezza della quale spero che non arriverà questa, della quale, per dir la verità, principio a vergognarmi. Ma la bontà ch’Ella m’ha dimostrata, mi fa animo, e tiro avanti.
Intorno alle regole generali, ecco quali furono, se la memoria non m’inganna, le principali proposizioni romantiche. Ogni regola, per esser ricevuta da uomini, debbe avere la sua ragione nella natura della mente umana. Dal fatto speciale, che un tale scrittor classico, in un tal genere, abbia ottenuto l’intento, toccata la perfezione, se si vuole, con tali mezzi, non se ne può dedurre, che quei mezzi devano pigliarsi per norma universale, se non quando si dimostri, che siano applicabili, anzi necessari in tutti i casi d’ugual genere; e ciò per legge dell’intelletto umano. Ora, molti di quei mezzi, di quei ritrovati messi in opera dai classici, furono suggeriti ad essi dalla natura particolare del loro soggetto, erano appropriati a quello, individuali per così dire; e l’averli trovati in quella occorrenza, è un merito dello scrittore, ma non una ragione per farne una legge; anzi è una ragione per non farnela. Di più, anche nella scelta dei mezzi, i classici possono avere errato; perchè no? e in questi casi, invece di cercare nel fatto loro una regola da seguire, bisogna osservare un fallo da evitarsi. A voler dunque profittare con ragione dell’esperienza, e prendere dal fatto un lume per il da farsi, si sarebbe dovuto distinguere nei classici ciò, che è di ragione perpetua, ciò, che è di opportunità speciale. Se questo discernimento fosse stato tentato e eseguito da de’ filosofi, converrebbe tener molto conto delle loro fatiche, senza però ricevere ciecamente le loro decisioni. Ma invece questa provincia è stata invasa, corsa, signoreggiata quasi sempre da retori estranei affatto agli studi sull’intelletto umano; e questi hanno dedotte dal fatto, inteso come essi potevano, le leggi che hanno volute; hanno ignorate, o repudiate le poche ricerche de’ filosofi in quella materia, o se ne sono impadroniti, le hanno commentate a loro modo, traviate, o anche qualche volta hanno messo sotto il nome e l’autorità di quelli le loro povere e strane prevenzioni. Ricevere senza esame, senza richiami, leggi di tali, e così create, è cosa troppo fuori di ragione. E quale in fatti, aggiungevano i Romantici, è l’effetto più naturale del dominio di queste regole? Di distrarre l’ingegno inventore dalla contemplazione del soggetto, dalla ricerca dei caratteri propri e organici di quello, per rivolgerlo e legarla alla ricerca e all’adempimento di alcune condizioni affatto estranee al soggetto, e quindi d’impedimento a ben trattarlo. E un tale effetto non è forse troppo manifesto? Queste regole non sono forse state per lo più un inciampo a quelli, che tutto il mondo chiama scrittori di genio, e un’arme in mano di quelli, che tutto il mondo chiama pedanti? E ogni volta che i primi vollero francarsi di quell’inciampo, ogni volta che, meditando sul loro soggetto, e trovandosi a certi punti, dove per non istorpiarlo era forza di violare le regole, essi le hanno violate, che n’è avvenuto? I secondi gli attendevano al varco; e senza esaminare, nè voler intendere il perchè di quelle che chiamavano violazioni; senza provare, nè saper nemmeno, che ad essi incumbeva di provare, che l’attenersi alla regola sarebbe stato un mezzo per trattar meglio quel soggetto, gridarono ogni volta contro la licenza, contro l’arbitrio, contro l’ignoranza dello scrittore. Ora, poichè ciò che ha data sempre tanta forza ai pedanti contro gli scrittori d’ingegno, è per l’appunto questo rispetto implicito per le regole, perchè, dicevano i Romantici, lasceremo noi sussistere una tale confusione, un tal mezzo per tormentare gli uomini d’ingegno? Non sono stati sempre tormentati più del bisogno?
Dall’altra parte, proseguivano, non è egli vero che, passato un certo tempo, quella stessa violazione delle regole, ch’era stata un capo d’accusa per molti scrittori, divenne per la loro memoria un soggetto di lode? che ciò che s’era chiamato sregolatezza, ebbe poi nome d’originalità? E, come nella questione della mitologia, allegavano anche qui la lode che noi italiani diamo a più d’uno de’ nostri poeti prediletti, e quella che altre colte nazioni danno ad alcuni de’ loro, d’avere abbandonate le norme comuni; d’essersi resi superiori a quelle; d’avere scelta una, o un’altra strada non tracciata, non preveduta, nella quale la critica non aveva ancora posti i suoi termini, perchè non la conosceva, e il genio solo doveva scoprirla? Se per questi, dicevano, il trasgredir le regole è stato un mezzo di far meglio, perchè s’avrà sempre a ripetere che le regole sono la condizione essenziale per far bene?
Alla conseguenza che i Romantici cavavano da questo fatto, mi ricordo, che si dava generalmente una risposta non nova, ma molto singolare: cioè che molte cose sono lecite ai grandi scrittori, ma ad essi soli; e che in ciò la loro pratica non è un esempio per gli altri. Le confesso, che non ho mai potuto comprendere la forza dell’argomento, che pare essere incluso in questa sentenza. Cercando la ragione per cui quei grandi scrittori hanno ottenuto l’effetto con la violazione delle regole, m’è sempre parso che la cagione fosse questa: che essi, vedendo nel soggetto una forma sua propria che non sarebbe potuta entrare nella stampa delle regole, hanno gettata via la stampa, hanno svolta la forma naturale del soggetto, e così ne hanno cavato il più e il meglio, che esso poteva dare al loro ingegno. Il lecito, l’illecito, la dispensa non veggo cosa ci abbiano a fare; mi paiono metafore che, in questo caso, non hanno un senso al mondo. Ora quella ragione non è per nulla particolare ai grandi ingegni, è universalissima, viene dalla natura stessa della cosa, indica il mezzo, con cui, e grandi e piccoli, ognuno secondo la sua misura, può fare il meglio possibile.
– Oh, i mediocri non arriveranno mai a scoprire in un argomento quella forma splendida, originale, grandiosa, che appare ai grandi ingegni. – Sia, col nome del cielo; non ci arriveranno; ma di che aiuto saranno ad essi le regole? O le sono ragionevoli, e in questo caso i grandi scrittori non se ne devono dispensare, perchè sarebbe privarsi d’un aiuto a trovare e a esprimere più potentemente quella forma: o le sono irragionevoli, e se ne devono dispensare anche i mediocri, perchè esse non potranno fare altro che impicciarli di più, allontanarli di più dalla verità del concetto, e mettere la storpiatura, dove senza di esse non sarebbe stato, che minor perfezione. Onde, quanto più penso a questa doppia misura di regole, obbligatorie per molti, e per alcuni no, tanto più mi pare fuor di proposito. Ed è, se non m’inganno, stata trovata per uscire d’impiccio: quando ci si fa vedere una contradizione tra due proposizioni, che affermiamo ugualmente; e quando non vogliamo nè confrontarle tra di loro, nè abbandonarne nessuna, nè sappiamo farle andar d’accordo, ne inventiamo una terza, la quale mette la pace tra le parole, se non tra le idee, non serve al ragionamento, ma serve a dare una risposta, che in fine è quello, che più preme. Ma se anche una tale strana distinzione si volesse ammettere, cosa farne poi in pratica? come applicarla nel fatto? L’uomo che, nell’atto del comporre si trova combattuto tra la regola, e il suo sentimento, dovrà egli proporsi questo curioso problema: Son io, o non sono un grand’uomo? E come scioglierlo poi? – Oh! si fidi al suo genio, se ne ha; e lasci dire. – Si fidi! Veramente l’esperienza può inspirar molta fiducia; e come possono dire, si fidi, quelli per l’appunto, che vogliono tenere in vigore tutti quei mezzi, che sono sempre stati adoprati a levare la fiducia ai più forti ingegni, e l’hanno realmente levata a più d’uno di loro? Lasci dire! Mi pare, che invece di consigliare que’ pochi infelici, che portano la croce del genio, a non curare le nostre parole, sarebbe tempo, che cominciassimo noi a pesarle un po’ più.
Ma io, dimenticando che parlo con un giudice, mi son lasciato andare un momento a garrire con degli avversari. Scusi di grazia questa scappata, e mi scusi anche del rimettermi nella strada d’infastidirla ancora qualche tempo.
Alle altre proposizioni messe in campo dai romantici contro le regole arbitrarie, non mi ricordo veramente, se qualche cosa si rispondesse, nè veggo che cosa si possa rispondere. Si diceva bene da molti, che il fine di quelle proposizioni era di sbandire ogni regola dalle cose letterarie, d’autorizzare, di promovere tutte le stravaganze, di riporre il bello nel disordinato. Che vuol Ella? A questo mondo è sempre stata usanza d’intendere e di rispondere a questo modo.
Prima d’abbandonare il discorso delle regole, mi permetta che Le sottoponga un’osservazione che non mi sovviene d’aver trovata proposta da altri: ed è, che il soggetto d’una questione, che dura da tanto tempo, non è stato mai definito con precisione. La parola: «regole», intorno alla quale si aggira la disputa, non ha mai avuto un senso determinato. Un uomo, che sentisse per la prima volta parlare di questa discussione intorno alle regole, dovrebbe certamente supporre, che fossero determinate in formule precise, descritte in un bel codice conosciuto e riconosciuto da tutti quelli, che le ammettono; tante nè più nè meno, tali e non altrimenti: perchè la prima condizione per far ricevere altrui una legge, è di fargliela conoscere. Ora Ella sa, se la cosa sia così. E se uno di quelli che ricusano questo dominio indefinito delle regole, dicesse a uno di quelli, che lo propugnano: sono convinto; questa parola regole, ha un non so che, che mi soggioga l’intelletto: mi rendo; e per darvi una prova della mia docilità, vi fo una proposizione la più larga, che in nessuna disputa sia stata fatta mai. Pronunziate a una a una le formule di queste regole adottate, come dite, da tutti i savi; e ad ognuna io risponderò: amen; certo, costui, con tanta sommissione apparente, farebbe all’altro una brutta burla, lo metterebbe in uno strano impiccio.
Sono ben lontano dal credere d’avere espressa una idea compita della parte negativa del sistema romantico. Molte cose saranno sfuggite alla mia osservazione, quando la questione si dibatteva: molte dopo, dalla memoria; e dell’altre ne ho omesse apposta, o perchè non potevano così naturalmente venire sotto quei pochi capi, che ho presi qui per tema, o anche, se non ad effetto, almeno ad intento di brevità. Pure oso credere, che anche il poco, che ho qui affoltato di quel sistema, basti a farne sentire il nesso, e l’importanza, a farci scorgere una vasta e coerente applicabilità d’un principio a molti fatti della letteratura, e una forse ancor più vasta e feconda applicabilità a tutti i fatti della letteratura stessa. Dovrei ora passare alla parte positiva, e spicciarmi; ma non mi posso ritener di parlare d’una obiezione, o, per dir meglio, di una critica, che si faceva al complesso delle idee, che ho toccate fin qui.
Si diceva che tutte quelle idee, quei richiami, tutte quelle proposte di riforma letteraria, erano cose vecchie, ricantate, sparse in cento libri. Che questa fosse una critica fatta alle persone, non una obiezione al sistema, è una cosa manifesta. La questione era, se certe idee fossero vere o false; cosa c’entrava, che fossero nove o vecchie? Riconosciuta la verità, o dimostrata la falsità delle idee, anche l’altra ricerca poteva esser utile alla storia delle cognizioni umane; ma anteporre questa ricerca, farne il soggetto principale della questione, era un cambiarla per dispensarsi dal risolverla. Di più questa taccia di plagiari che si dava ai Romantici, faceva a’ cozzi con quella di novatori temerari che si dava loro ugualmente. E a ogni modo, non esito a dirla ingiusta. Non parlerò dell’idee nove messe in campo da quelli; le opposizioni stesse ne provocarono assai. Ma il nesso delle antiche; ma la relazione scoperta e indicata tra di esse; ma la luce e la forza reciproca, che venivano a tutte dal solo fatto di dassificarle sotto ad un principio, il sistema insomma, da chi era stato immaginato, da chi proposto, da chi ragionato mai? Dalle ricchezze intellettuali sparse, dal deposito confuso delle cognizioni umane, raccogliere pensieri staccati e accidentali, verità piuttosto sentite che comprese, accennate piuttosto che dimostrate; subordinarle a una verità più generale, che riveli tra di esse un’associazione non avvertita in prima; cambiare i presentimenti di molti uomini d’ingegno in dimostrazioni, levare a molte idee l’incertezza, e l’esagerazione; sceverare quel misto di vero e di falso, che le faceva rigettare in tutto da molti, e ricevere in tutto da altri con un entusiasmo irragionevole; collocarle con altre, che servono ad esse di limite e di prova a un tempo, non è questa la lode d’un buon sistema? e è forse una lode tanto facile a meritarsi? E chi mai ha desiderato, o immaginato un sistema, che non contenesse, fuorchè idee tutte nove?
Del resto, non c’è qui da vedere un’ingiustizia particolare: l’accusa di plagio è stata fatta sempre agli scrittori, che hanno detto il più di cose nove; sempre s’è andato a frugare ne’ libri antecedenti, per trovare che il tal principio era stato già immaginato, insegnato, ecc.; sempre si è detto ch’era la centesima volta, che quelle idee venivano proposte. E che avrebbero potuto rispondere quegli scrittori? Tal sia di voi, che siete stati sordi le novantanove; tal sia di voi, che, avendo in tanti libri tutte queste idee, non ne tenevate conto, e continuavate a ragionare come se non fossero mai state proposte. Ora noi v’abbiamo costretti ad avvertirle; quando non si fosse fatto altro, questo almeno è quacosa di novo.
Se alcuno volesse provare che il merito da me accennato poco sopra, e altri simili, non si trovano nel sistema romantico, credo che ascolterei le sue prove con molta curiosità, e con una docilità spassionata; ma finora ciò non è, ch’io sappia, stato nè fatto nè tentato. Intanto non posso a meno di non ravvisarci quel merito; e m’accade spesso, leggendo opere letterarie, precettive, o polemiche, anteriori al sistema romantico, d’abbattermi in idee molto ragionevoli, ma independenti dalla dottrina generale del libro, idee volanti, per dir così, le quali, in quel sistema, sono collocate razionalmente, e ci sono divenute stabili e feconde. Similmente, ne’ libri di scrittori ingegnosi, ma paradossai di professione, m’accade spesso di trovare di quelle opinioni speciose e vacillanti, che da una parte hanno l’aria d’una verità triviale, e dall’altra d’un errore strano; e di riflettere con piacere, che quelle opinioni trasportate nel sistema romantico, ci sono legate e temperate in modo, che il vero ne è conservato e appare più manifesto e importante, e il falso, lo strano ne sono naturalmente recisi e esclusi. Con tutto ciò la parte negativa è, senza dubbio, la più notabile del sistema romantico, almeno del trovato e esposto fino ad ora.
Il positivo non è a un bon pezzo, nè così preciso, nè così diretto, nè sopra tutto così esteso. Oltre quella condizione generale dell’intelletto umano, che lo fa essere più attivo nel distruggere, che nell’edificare, la natura particolare del sistema romantico doveva produrre questo effetto. Proponendosi quel sistema d’escludere tutte le norme, che non siano veramente generali, perpetue, ragionevoli per ogni lato, viene a renderne più scarso il numero, o almeno più difficile e più lenta la scelta. Un’altra cagione fu la breve durata della discussione, e il carattere, che prese fino dal principio. Come il negativo era naturalmente il primo soggetto da trattarsi, così occupò quasi interamente quel poco tempo. La discussione poi prese pur troppo un certo colore di scherno, come per lo più accade; ora in tutte le questioni trattate schernevolmente c’è più vantaggio nell’attaccare, che nel difendere: quindi i romantici furono naturalmente portati a diffondersi, e a insistere più nella parte negativa, nella quale, per dir la verità, trovavano da sguazzare; e quanto al positivo furono portati a tenersi a de’ principi generalissimi, che danno meno presa a cavillazioni e a parodie. Non potè per questo il sistema romantico evitare neppur esso la derisione; ma almeno quelli, che vollero deriderlo, furono costretti a esagerarlo, o piuttosto a inventarne uno, loro, e ad apporlo a chi non lo aveva mai nè proposto, nè sognato; metodo tanto screditato, ma d’una riuscita quasi infallibile, e che probabilmente si smetterà alla fine del mondo.
Se la disputa fosse continuata, o, per dir meglio, se, invece d’una disputa si fosse fatta una investigazione comune, dall’escludere si sarebbe passati al proporre, anzi in questo si sarebbe fissata la maggiore intenzione degli ingegni. E allora, si potrebbe credere che le opinioni sarebbero state tanto più varie quanto più abbondanti; e che molti ingegni, movendo da un centro comune, si sarebbero però avviati per tanti raggi diversi, allontanandosi anche talvolta l’uno dall’altro a misura che si sarebbero avanzati: tale è la condizione delle ricerche intellettuali intraprese da molti. Ma il sistema romantico non potè arrivare, o piuttosto, non arrivò a questo periodo. E ciò non ostante, un gran rimprovero, che veniva fatto ai suoi sostenitori, era, che non s’intendevano nemmeno fra di loro: cominciassero, si diceva, ad accordarsi perfettamente nelle idee, prima di proporle agli altri come verità. Rimprovero, al quale non posso tuttavia pensare senza maraviglia. In regola generale, quelli, che così parlavano, chiedevano una cosa che l’ingegno non ha data, nè può dar mai. Mai questa concordia perfetta di più persone in tutti i punti d’un sistema morale non ha avuto luogo: bisognerebbe, a ottenerla, che per tutti questi punti si adottassero da ciascheduno altrettanti giudizi, altrettante formule uniche e invariabili; anzi che tanti uomini diventassero uno solo, per potere a ogni novo caso fare una identica applicazione di quei giudizi generici. C’è bene un ordine di cose, nel quale esiste una essenziale e immutabile concordia; ma quest’ordine è unico; i suoi caratteri, le sue circostanze sono incomunicabili. Quest’ordine è la religione: essa dà una scienza, che l’intelletto non potrebbe scoprire da sè, una scienza, che l’uomo non può ricevere, che per rivelazione, e per testimonianza; ora una sola rivelazione include una sola dottrina, e quindi produce una sola credenza. E anche in quest’ordine, la concordia delle menti non è comandata, se non dove è sommamente ragionevole; cioè in quei punti, nei quali la verità non si può sapere, che per la testimonianza di chi ne ha ricevuta la rivelazione, cioè della Chiesa; e non è comandata questa concordia, se non dal momento, che l’unico testimonio ha parlato. Ma, nelle cose umane, questo testimonio non esiste; non è stata nè fatta, nè promessa ad alcuno una comunicazione di scienza, un’assistenza nelle decisioni; quindi i giudizi variano secondo la varietà degl’ingegni, e riescono generalmente così dissimili, che a chiamar uno un sistema, non si ricerca mai il fatto impossibile, che esso riunisca tutti i giudizi in una materia qualunque, ma il fatto difficile e raro, che ne riunisca molti, nei punti principali di essa.
Nel caso particolare poi del sistema romantico rimprovero mi pareva molto stranamente applicato. Se quelli, che lo facevano, avessero voluto riandare la storia de’ sistemi umani, avrebbero trovato, io credo, che pochi furono quelli, che presentassero meno dissentimenti del romantico. Se avessero fatto solamente un po’ d’esame sul sistema chiamato classico, al quale volevano, che si dasse la preferenza, avrebbero potuto veder subito quanto più gravi e più numerosi siano in quello i dispareri, le incertezze, le varie applicazioni; avrebbero veduto, quanto sarebbe più difficile il ridurlo a formule generali, il comporne una, per dir così, confessione, che fosse comunemente ricevuta da coloro che ricevono la parola classico. E se avessero voluto voltarsi indietro a ricercar le cagioni d’una tale differenza tra le due dottrine, o opinioni, avrebbero dovuto, da una parte, riconoscere che questo non poter la loro esser ridotta in una forma sintetica, nemmeno apparente, veniva dall’essere, non una applicazione di principi a un complesso di casi speciali, ma un miscuglio di fatti accidentali, convertiti in princìpi; e per una certa quale consolazione (solatia victis), avrebbero potuto osservare che una cagione del vantaggio che avevano in questo i romantici, era il fatto già accennato anche qui, cioè il non essere andati molto avanti nell’applicazioni speciali e distinte al da farsi, dove sarebbero potute, o dovute nascer le discordanze, come tra degli alleati, uniti nel combattere un nemico comune, le cose s’imbrogliano quando, dopo la vittoria, si viene a trattare della distribuzione de’ territori conquistati.
Dove poi l’opinioni de’ romantici erano unanimi, m’è parso, e mi pare, che fosse in questo: che la poesia deva proporsi per oggetto il vero, come l’unica sorgente d’un diletto nobile e durevole; giacchè il falso può bensì trastullar la mente, ma non arricchirla, nè elevarla; e questo trastullo medesimo è, di sua natura, instabile e temporario, potendo essere, come è desiderabile che sia, distrutto, anzi cambiato in fastidio, o da una cognizione sopravvegnente del vero, o da un amore cresciuto del vero medesimo. Come il mezzo più naturale di render più facili e più estesi tali effetti della poesia, volevano che essa deva scegliere de’ soggetti che, avendo quanto è necessario per interessare le persone più dotte, siano insieme di quelli per i quali un maggior numero di lettori abbia una disposizione di curiosità e d’interessamento, nata dalle memorie e dalle impressioni giornaliere della vita; e chiedevano, per conseguenza che si desse finalmente il riposo a quegli altri soggetti, per i quali la classe sola de’ letterati, e non tutta, aveva un’affezione venuta da abitudini scolastiche, e un’altra parte del pubblico, non letterata nè illetterata, una reverenza, non sentita, ma cecamente ricevuta.
Non voglio dissimulare nè a Lei (che sarebbe un povero e vano artifizio) nè a me stesso, perchè non desidero d’ingannarmi, quanto indeterminato, incerto, e vacillante nell’applicazione sia il senso della parola «vero» riguardo ai lavori d’immaginazione. Il senso ovvio e generico non può essere applicato a questi, ne’ quali ognuno è d’accordo che ci deva essere dell’inventato, che è quanto dire, del falso. Il vero, che deve trovarsi in tutte le loro specie, et même dans la fable, è dunque qualche cosa di diverso da ciò, che si vuole esprimere ordinariamente con quella parola, e, per dir meglio, è qualche cosa di non definito; nè il definirlo mi pare impresa molto agevole, quando pure sia possibile. Comunque sia, una tale incertezza non è particolare al principio che ho tentato d’esporle: è comune a tutti gli altri, è antica; il sistema romantico ne ritiene meno di qualunque altro sistema letterario, perchè la parte negativa, specificando il falso, l’inutile, e il dannoso, che vuole escludere, indica, e circoscrive nelle idee contrarie qualcosa di più preciso, un senso più lucido di quello, che abbiamo avuto finora. Del resto, in un sistema recente, non si vuol tanto guardare agli svolgimenti, che possa aver già ricevuti, quanto a quelli, di cui è capace. La formula che ne esprime principio, è così generale; le parole di essa hanno, se non altro un suono, un presentimento così bello e così savio; il materiale dei fatti, che devono servire agli esperimenti, è così abbondante, che è da credersi, che un tale principio sia per ricevere, di mano in mano, svolgimenti, spiegazioni e conferme, di cui ora non è possibile prevedere in concreto, nè il numero, nè l’importanza. Tale almeno è l’opinione, che ho fitta nella mente, e che m’arride anche perchè in questo sistema, mi par di vedere una tendenza cristiana.
Era questa tendenza nelle intenzioni di quelli, che l’hanno proposto, e di quelli, che l’hanno approvato? Sarebbe leggerezza l’affermarlo di tutti, poichè in molti scritti di teorie romantiche, anzi nella maggior parte, le idee letterarie non sono espressamente subordinate al cristianesimo; sarebbe temerità il negarlo, anche d’uno solo, perchè in nessuno di quegli scritti, almeno dei letti da me, il cristianesimo è escluso. Non abbiamo, nè i dati, nè il diritto, nè il bisogno di fare un tal giudizio: quella intenzione, certo desiderabile, certo non indifferente, non è però necessaria per farci dare la preferenza a quel sistema. Basta, che quella tendenza ci sia. Ora, il sistema romantico, emancipando la letteratura dalle tradizioni pagane, disobbligandola, per dir così, da una morale voluttuosa, superba, feroce, circoscritta al tempo, e improvida anche in questa sfera; antisociale, dov’è patriottica, e egoista, anche quando non è ostile; tende certamente a render meno difficile l’introdurre nella letteratura le idee, e i sentimenti, che dovrebbero informare ogni discorso. E dall’altra parte, proponendo anche in termini generalissimi il vero, l’utile, il bono, il ragionevole, concorre, se non altro, con le parole, allo scopo del cristianesimo; non lo contraddice almeno nei termini. Per quanto una tale efficacia d’un sistema letterario possa essere indiretta, oso pur tenermi sicuro, ch’Ella non la giudicherà indifferente, Ella che, senza dubbio, avrà più volte osservato, quanto influiscano sui sentimenti religiosi i diversi modi di trattare le scienze morali, che tutte alla fine hanno un vincolo con la religione, quantunque distinzioni e classificazioni arbitrarie possano separarle da essa in apparenza, e in parole; Ella che avrà più volte osservato, come, senza parere di toccare la religione, senza neppure nominarla, una scienza morale prenda una direzione opposta ad essa, e arrivi a conclusioni che sono inconciliabili logicamente con gl’insegnamenti di essa; e come poi, qualche volta, avanzandosi e dirigendosi meglio nelle scoperte, rigetti quelle conclusioni e venga così a conciliarsi con la religione e, di novo, senza neppur nominarla, e senza avvedersene. Non so s’io m’inganni, ma mi pare, che più d’una scienza faccia ora questo corso felicemente retrogrado. L’economia politica, per esempio, nel secolo scorso, aveva, in molti punti, adottati quasi generalmente, de’ canoni opposti affatto al Vangelo; e li proponeva con una tale asseveranza, con un tale impero, con tali minacce di compassione sprezzante per chi esitasse nell’ammetterli, che molti deboli, ricevendo quei canoni, furono persuasi che la scienza del Vangelo fosse corta e meschina; che i suoi precetti non avessero potuto comprendere tutto il possibile svolgimento delle relazioni sociali; e molti altri, credendo di adottare verità puramente filosofiche, adottavano, con una docilità non ragionevole, delle dottrine opposte al Vangelo. Ed ecco, che, per un progresso naturale delle scienze economiche, per un più attento e esteso esame dei fatti, per un ragionato cambiamento di princìpi, altri scrittori, in questo secolo, hanno scoperta la falsità, e il fanatismo di quei canoni; e sul celibato, sul lusso, sulla prosperità fondata nella rovina altrui, sopra altri punti ugualmente importanti, hanno stabilite dottrine conformi ai precetti, e allo spirito del Vangelo; e, s’io non m’inganno, quanto più quella scienza, diventa ponderata e filosofica, tanto più diventa cristiana. E quanto più considero, tanto più mi pare, che il sistema romantico tenda a produrre, e abbia cominciato a produrre nelle idee letterarie un cambiamento dello stesso genere.
Se dovessi scrivere questi pensieri per la stampa, mi troverei costretto a soggiunger qui subito molte restrizioni, perchè altri non credesse, o non volesse credere, ch’io intenda, che il sistema romantico renderà spirituale tutta la letteratura, farà dei poeti tanti missionari, ecc. Ma scrivendo a Lei, se diffido delle mie idee, ho almeno la sodisfazione d’esser certo, che saranno prese secondo la loro misura; e in tante lungaggini, posso almeno risparmiarle quelle, che sarebbero destinate a prevenire le false interpretazioni, e quell’affettato frantendere che molti trovano più comodo e più furbo dell’intendere.
Dopo d’averle, a diritto e a rovescio, e forse con più fiducia che discrezione, sottomesso il mio parere sopra una materia toccata appena indirettamente nella gentilissima di Lei lettera, non so, se mi rimanga ancora qualche diritto di parlare del punto ch’Ella ha accennato più espressamente, voglio dire il trionfo, o la caduta probabile del sistema romantico. Ma, giacchè in più luoghi di questa cicalata, mi sono preso la libertà di proferire, con molta confidenza, de’ pronostici lieti per quel sistema, i quali a prima vista, possono parere in opposizione col fatto, non posso a meno di non sottometterle anche le ragioni di quei pronostici, quali mi par di vederle nello stato reale delle cose, rimosse le prime apparenze.
Certo, se uno straniero, il quale avesse sentito parlare dei dibattimenti, ch’ebbero luogo qui intorno al romanticismo, venisse ora a domandare a che punto sia una tale questione, si può scommettere mille contr’uno, che si sentirebbe rispondere a un dipresso così: – Il romanticismo? Se n’è parlato qualche tempo, ma ora non se ne parla più; la parola stessa è dimenticata, se non che di tempo in tempo vi capiterà forse di sentire pronunziar l’epiteto romantico per qualificare una proposizione strana, un cervello bislacco, una causa spallata; che so io? una pretesa esorbitante, un mobile mal connesso. Ma non vi consiglierei di parlarne sul serio: sarebbe come se veniste a chiedere, se la gente si diverte ancora col Kaleidoscopio. – Se l’uomo, che avesse avuta questa risposta, fosse di quelli che sanno ricordarsi all’opportunità, che una parola si adopera per molti significati, e insistesse per sapere, che cosa intenda per romanticismo il suo interlocutore, vedrebbe, che intende non so qual guazzabuglio di streghe, di spettri, un disordine sistematico, una ricerca stravagante, una abiura in termini del senso comune; un romanticismo insomma, che si sarebbe avuta molta ragione di rifiutare, e di dimenticare, se fosse stato proposto da alcuno.
Ma, se per romanticismo si vuole intendere la somma delle idee, delle quali Le ho male esposta una parte, questo, non che esser caduto, vive, prospera, si diffonde di giorno in giorno, invade a poco a poco tutte le teorie dell’estetica; i suoi risultati sono più frequentemente riprodotti; applicati, posti per fondamento dei diversi giudizi in fatto di poesia. Nella pratica poi non si può non vedere una tendenza della poesia stessa a raggiunger lo scopo indicato dal romanticismo, a cogliere e a ritrarre quel genere di bello, di cui le teorie romantiche hanno dato un’idea astratta, fugace, ma che basta già a disgustare delI’idea che le è opposta. Un altro indizio manifesto della vita, e del vigore di quel sistema sono gli applausi dati universalmente a de’ lavori, che ne sono l’applicazione felice. Ne citerò un esempio, per il piacere, che provo nel rammentare la giustizia resa al lavoro d’un uomo, a cui mi lega un’amicizia fraterna. Quando comparve l’Ildegonda, bollivano le questioni sul romanticismo; e non sarebbe stata gran maraviglia, se l’avversione di molti alla teoria avesse prevenuto il loro giudizio contro un componimento, che l’autore non dissimulava d’aver concepito secondo quella. Eppure la cosa andò ben altrimenti; le opinioni divise sulla teoria furono conformi (moralmente parlando) in una specie d’amore pel componimento. E ora, passato già più tempo di quello che sia generalmente concesso alle riuscite effimere, quel favore, mi pare di poter dire, quell’entusiasmo, è divenuto una stima, che sembra dover esser perpetua. In tutta la guerra del romanticismo, non è dunque perita che la parola. Non è da desiderarsi che venga in mente ad alcuno, di risuscitarla: sarebbe un rinnovare la guerra, e forse un far danno all’idea che, senza nome, vive e cresce con bastante tranquillità.
Eccomi una volta al termine. Il rimorso continuo di tanta prolissità mi ha forzato tante volte a chiederlene scusa, che le scuse stesse sono divenute allungamenti; e non oso più ripeterle. Si degni Ella di gradire invece l’espressione del sincero ossequio, e della viva gratitudine, che Le professo, e d’accogliere il desiderio che nutro, di poter, quando che sia, esprimerle a voce questi sentimenti, coi quali ho l’onore di rassegnarmele
P. S. Per non ritardare davvantaggio la risposta alla gentilissima di Lei lettera, lascio partir questa, quale è, sparsa di sgorbi, e di cancellature. Ella me ne scuserà, ricordandosi che non si può mostrare altrui benevolenza, com’Ella ha fatto con me, senza ispirargli un poco di famigliarità.
Brusuglio, 22 settembre 1823.
Devotissimo e obbligatissimo servitore
Alessandro Manzoni
Fonte
Biblioteca Italiana, 2008
Tratto da
Alessandro Manzoni, Scritti linguistici e letterari, a cura di Carla Riccardi e Biancamaria Travi, Mondadori, Milano 1991
Testi pubblicati per studio e ricerca – Uso non commerciale
Categorie:Uncategorized
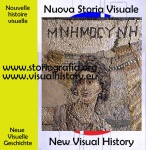

Lascia un commento