La solitudine del Papa. Il caso irrisolto della morte
di Papa Luciani
“Tempestas magna est super me”
Uno dei temi che forse più appassioneranno gli storici del futuro è quello della solitudine del Papa nella Curia romana, che ogni tanto emerge nella storia della chiesa, specie nel secolo appena trascorso e in questo. Ultimo in ordine di tempo è il caso della rinuncia di Papa Ratzinger. Ma quello più drammatico riguarda il caso di Papa Luciani (1912 – 1978).
L’improvvisa morte di papa Giovanni Paolo I, all’età di 66 anni, avvenuta nella notte del 28 settembre 1978, dopo soli 33 giorni dalla sua elezione al soglio pontificio, ha dato via a tutta una serie di ipotesi e speculazioni.
Stando alle fonti Vaticane, papa Luciani morì tra le ore 21:30 del 28 settembre 1978 e le ore 4:45 del giorno successivo nei suoi appartamenti, per Infarto miocardico acuto. A scoprire il Pontefice morto nel suo letto sarebbe stato il suo secondo segretario personale John Magee; sul suo comodino era posata una copia dell’Imitazione di Cristo, opera medievale che, dopo la Bibbia, è il testo più diffuso di tutta la letteratura cristiana occidentale. In realtà venne trovato da una suora incaricata di portagli da bere e a cui fu imposto di tacere per ordine del silenzio religioso.
Il decesso venne annunciato dal seguente comunicato:
| « Questa mattina, 29 settembre 1978, verso le 5,30, il segretario privato del Papa, non avendo trovato il Santo Padre nella cappella del suo appartamento privato, lo ha cercato nella sua camera e lo ha trovato morto nel letto, con la luce accesa, come se fosse intento a leggere. Il medico, dott. Buzzonetti, accorso immediatamente, ne ha constatato il decesso, avvenuto presumibilmente verso le 11 di ieri sera, per infarto acuto del miocardio. » |
| (Comunicato ufficiale della Sala Stampa della Santa Sede) |
Dopo la morte del Papa, il collegio cardinalizio prese la decisione di non autorizzare l’autopsia, che avrebbe potuto accertare le cause del decesso; non valse la gisutificazione che non si fosse mai fatta in precedenza l’autopsia sul corpo di un papa perché c’era il precedente storico di Pio VIII (1761 – 1830). Fin dalla sua elezione Pio VIII ebbe salute cagionevole. Nonostante ciò, le circostanze della sua morte dettero adito alla supposizione che fosse stato vittima di un avvelenamento. Il principe Chigi, contemporaneo del papa e dignitario accreditato presso la corte pontificia, annotò nel suo diario del giorno 2 dicembre 1830:
| « Nella sezione del cadavere del Pontefice che seguì ieri sera per quanto si dice, furono trovate le viscere sanissime e solo si è rinvenuta qualche debolezza nel polmone, altri dicono qualche sfiancamento nel cuore; resterebbe perciò a sapersi di qual male sia morto. » |
Queste parole furono da alcuni interpretate come indizio dell’esistenza di un complotto.
Tornando a Papa Luciani, successivamente, grazie alle testimonianze di chi era presente quella notte nella camera da letto del defunto, emersero alcune imprecisioni nella versione ufficiale dei fatti. La prima a trovare il papa morto sarebbe stata in realtà la fedele suor Vincenza Taffarel; inoltre sul suo comodino non ci sarebbe stato il summenzionato testo medievale ma dei fogli contenenti appunti e annotazioni personali. Chi ha compilato il comunicato ufficiale avrebbe preferito sorvolare sulla presenza di una donna (Suor Vincenza) nella stanza del Papa.
Anche la causa del decesso, ovvero l’infarto del miocardio, venne contestata: sebbene sia una patologia che può sopraggiungere improvvisamente anche in una persona sana, essa lascia segni visibili di sofferenza su chi lo subisce, segni che nessuno riscontrò in Luciani. C’è chi a proposito sostiene l’ipotesi dell’embolia polmonare, che provoca una morte quasi istantanea: un’embolia, in questo caso ad un occhio, già aveva colpito Luciani nel 1975 di ritorno da un viaggio in Brasile.
Gli errori, le incongruenze, le omissioni della versione ufficiale, la mancata autopsia e soprattutto il clima dell’Italia dell’epoca, immersa nei difficili anni di piombo, favorirono l’emergere, dopo alcuni mesi, di varie versioni alternative a quella ufficiale, alcune delle quali complottiste e cospirazioniste. Versioni che chiamano in causa in particolar modo la massoneria, la mafia, i servizi segreti.
Le testimonianze sullo stato di salute di Giovanni Paolo I risultano estremamente discordanti.
Prima di essere eletto Pontefice, Albino Luciani era stato sottoposto a una serie di interventi chirurgici ma presentava un quadro clinico decisamente buono, anche se da alcuni ritenuto alquanto cagionevole; quel che è certo è che negli anni immediatamente precedenti alla sua elezione la sua salute era del tutto stabile, anche perché in caso di infermità o cagionevolezza il Conclave non avrebbe proceduto all’investitura pontificale, visto il notevole impegno richiesto dalla carica.
I parenti di Luciani non escludono la naturalità del decesso improvviso, posto che sostengono l’esistenza di almeno altri due casi, nella loro famiglia, di decessi improvvisi senza alcun particolare elemento premonitore. L’ipotesi da essi sostenuta propende per un’embolia, anche alla luce del fatto, di cui si è già fatto cenno poc’anzi, che tre anni prima del suo decesso all’allora card. Luciani era stato riscontrato un embolo a un occhio: lui stesso aveva considerato con la sorella Nina che se quell’embolo si fosse fermato nel cuore o nei polmoni, egli sarebbe morto istantaneamente, senza nemmeno accorgersene.
Nel 1987, durante la trasmissione “Giallo” condotta da Enzo Tortora, uno dei segretari privati di Giovanni Paolo I, Don Diego Lorenzi, asserì che la sera precedente il suo decesso, intorno alle 18.30, il papa aveva ricevuto in udienza privata il segretario di Stato Vaticano, cardinale Villot, per poi congedarlo dopo circa un’ora, alle 19.30.
Al termine dell’udienza, Luciani avrebbe esternato a Lorenzi i sintomi di un malessere in termini di “dolori e fitte al centro del petto, con un senso di forte peso e oppressione”.
La dichiarazione scatenò un gran numero di polemiche: innanzitutto perché si trattava dell’unica testimonianza che deponesse in tal senso, posto che tutti coloro che avevano interagito col papa, fino al momento in cui si era ritirato nelle sue stanze private, non avevano mancato di evidenziarne l’apparente ottimo stato di salute; secondariamente, per via dell’intempestività della dichiarazione di padre Lorenzi, giunta a quasi dieci anni di distanza dalla morte del pontefice, peraltro giustificata dall’interessato con l’affermazione:
| « Non l’ho mai rivelato a nessuno perché nessuno è mai venuto a chiedermi spiegazioni o lumi al riguardo » |
In terzo luogo, poiché poche ore prima del suo decesso (e poco dopo l’asserita esternazione di malessere a Don Diego Lorenzi), alle 21.30 del 28 settembre il papa aveva parlato al telefono con il suo medico personale, il dott. Antonio Da Ros, il quale ripeterà a più riprese nel corso degli anni che in quell’occasione Giovanni Paolo I non aveva fatto il minimo riferimento a dolori, oppressioni o malesseri di sorta.
La causa naturale della morte fu spiegata in privato dal cardinale Giuseppe Siri, arcivescovo di Genova: il nuovo Papa, persona di estrema semplicità evangelica, aveva una spiccata emotività, come risulta dal fatto che arrossiva al trovarsi in situazioni che potevano essere motivo di vergogna e non ne fece mai mistero, ammettendolo anche durante una sua celebre udienza papale.
Papa Luciani, a detta del cardinal Siri, avrebbe confermato sine die le cariche curiali occupate dai cardinali nelle congregazioni romane; ciò l’avrebbe portato a ritrovarsi contornato di persone che non godevano della sua piena stima e fiducia, e il cuore non avrebbe retto a questa angosciosa situazione.
Cesare Musatti, nella sua celebre rievocazione a transazione psicanalitica della morte di papa Luciani, parla di una sorta di sublime fuga mistica, la cui simbologia è rappresentata dalla presenza sul suo comodino dell’Imitazione di Cristo, e soprattutto da quel fatale numero trentatré che rappresenta la sintesi di una identificazione totale con il Cristo, unico vero porto di salvezza, in questo caso dalle fauci di una corte che non risparmiava occasioni, ritiene il Musatti, per fargli presente la sua inadeguatezza.
Musatti ritiene che Luciani fosse una persona umile e semplice, ma non un sempliciotto e neanche uno sprovveduto; tuttavia, al di fuori della dimensione pastorale (l’unica nella quale si sentiva a suo agio, da vero sacerdote), non era particolarmente brillante nei rapporti umani. C’è chi conclude che effettivamente sarebbe stato lasciato solo, persino dai suoi segretari. In questa visione, l'”uscita” di papa Luciani è interpretata come drammaticamente coerente e misteriosa al tempo stesso, non nel significato dato da Yallop e altri, quanto in quello di trovare “nella profezia che si avvera” l’unico rimedio di salvezza, mediante un olocausto che Musatti ritiene non sia stato vano nella vita della chiesa. Le debolezze fisiche (cuore, polmoni, ecc.) di Luciani e la probabile caduta, in una situazione di estremo stress, delle difese immunitarie, non sarebbero state altro che un facile veicolo di realizzazione di questo inconscio sacrificio.
La più celebre tesi alternativa alla versione ufficiale riguarda un presunto complotto a sfondo politico terminato con un omicidio.
Questo sarebbe stato commissionato in quanto Luciani, sostenitore di un’idea di “banca etica” fin dai tempi del suo episcopato vittoriese, pochi giorni prima di morire avrebbe convocato i principali responsabili delle finanze vaticane per verificare come venivano gestiti gli introiti curiali, ma senza fare in tempo ad approfondire l’argomento.
Il papa infatti fin dai primi giorni di pontificato aveva espresso la necessità di un ritorno ad una povertà evangelica per la Chiesa, affermando di voler procedere ad una profonda revisione della presenza del Vaticano nei mercati finanziari mondiali, gestione in quegli anni affidata all’arcivescovo statunitense Paul Marcinkus, a capo dello I.O.R., e di voler devolvere ai paesi poveri l’1% degli introiti del clero. Secondo papa Luciani, infatti, «Lo IOR deve essere integralmente riformato. La Chiesa non deve avere potere, né possedere ricchezze. Il mondo deve sapere le finalità dello IOR, come vengono raccolti i denari e come vengono spesi. Si deve arrivare alla trasparenza …».
Particolarmente sgradite, inoltre, erano le idee innovative e riformiste espresse da papa Giovanni Paolo I, in particolare quelle attinenti alla riforma della Curia, della nomina cardinalizia di alcuni vescovi dell’Africa, dell’Asia e delle Americhe, sul ruolo della donna e sul tema della contraccezione, sulla quale aveva espresso timide aperture nella commissione sul controllo delle nascite al Concilio Vaticano II parlando di “maternità responsabile” (in parziale disaccordo con l’Humanae Vitae di Paolo VI), nonché a seguito di un convegno delle Nazioni Unite sulla sovrappopolazione mondiale.
Su queste basi, sei anni dopo la morte di Luciani, il giornalista investigativo britannico David Yallop pubblicò il best-seller In nome di Dio, dove esponeva la tesi secondo la quale la morte sarebbe da attribuirsi ad avvelenamento, probabilmente ad azione cardiaca (del tipo della Digitale), e il delitto sarebbe riconducibile ad ambienti massonici deviati, legati alla P2 di Licio Gelli.
L’elezione di Luciani avrebbe scontentato parecchi esponenti della gerarchia e degli ambienti vaticani. Tra questi, monsignor Marcinkus, che fino all’ultimo istante sperò nell’elezione di un altro candidato, Giuseppe Siri, esponente dell’ala tradizionalista e delfino di Pio XII.
L’arcivescovo statunitense, figura di spicco nel panorama della finanza vaticana, protagonista delle relazioni dell’Istituto per le Opere di Religione (IOR, la Banca Vaticana) con le grandi banche straniere per l’accrescimento dei capitali gestiti dall’Istituto, intuì immediatamente il potenziale pericolo rappresentato (a lui è stata attribuita la frase “Questo Papa non è come quello di prima, vedrete che le cose cambieranno“) dall’elezione di Luciani che, sin dai suoi primi discorsi, aveva appunto lasciato chiaramente trasparire l’intenzione di ricondurre la chiesa cattolica agli ideali di carità cristiana del primo cristianesimo, rifiutando l’ingerenza della Chiesa negli affari economici internazionali e respingendo ogni gestione speculativa dei suoi beni, alla stregua di una banca qualunque, nonché di contrastare fermamente l’appartenenza di ecclesiastici alla massoneria. Di personaggi come Roberto Calvi e Michele Sindona, Luciani aveva approfondito la conoscenza disponendo apposite indagini; subito dopo la sua elezione, il periodico OP-Osservatore Politico (secondo molti “strumento di comunicazione” dei servizi segreti italiani per veicolare messaggi all’ambiente politico) pubblicò un ampio servizio riportando un elenco di 131 ecclesiastici iscritti alla massoneria, in buona parte componenti l’entourage papale, fra cui Jean-Marie Villot (cardinale segretario di Stato), Agostino Casaroli (capo del ministero degli Affari Esteri del Vaticano), Pasquale Macchi (segretario di Paolo VI), monsignor Donato De Bonis (alto esponente dello I.O.R.), Ugo Poletti (vicario generale di Roma), don Virgilio Levi (vicedirettore de L’Osservatore Romano) e Roberto Tucci (direttore di Radio Vaticana). Direttore di O.P. era Mino Pecorelli, ucciso in circostanze misteriose un anno dopo l’elezione di Luciani e la cui morte viene ricondotta al caso Moro.
Yallop nel libro evidenziò le già citate incongruenze tra la versione ufficiale del Vaticano e le dichiarazioni dei testimoni oculari:
- Luciani, come già affermato in precedenza, sarebbe stato trovato morto con in mano il testo medievale Imitazione di Cristo, poi si parlò di fogli di appunti, quindi di un discorso per i gesuiti e, infine, di un elenco di eccellenti nomine e rimozioni che sarebbero state rese note l’indomani.
- L’ora della morte fu inizialmente fissata verso le 23, poi posticipata alle 4.
- Il corpo senza vita del Papa sarebbe stato scoperto dal secondo segretario, John Magee; si disse poi invece che a trovarlo fu una delle suore che gli prestavano assistenza.
Al crescere dei sospetti e degli interrogativi sulla morte di Luciani, la stampa italiana e una parte del clero si spinse a chiedere l’autopsia della salma del Pontefice, ipotesi respinta a gran voce dal collegio cardinalizio.
L’inchiesta di Yallop evidenziò, inoltre, numerose incongruenze e circostanze poco chiare, come la scomparsa di tutti gli oggetti personali dalla camera del Papa (occhiali, pantofole, appunti, il flacone di Effortil, un farmaco per l’ipotensione): la prima autorità a poter entrare nella stanza del defunto fu il segretario di Stato, Jean-Marie Villot (figurante nella lista dei cardinali-massoni pubblicata da O.P.), accompagnato da suor Vincenza Taffarel, indicata quale autrice materiale delle sottrazioni.
Sulla scrivania di Luciani venne ritrovata una copia del settimanale «Il Mondo» aperta su un articolo titolato «Santità… è giusto?», un documento-inchiesta circa la dubbia moralità dei fini perseguiti dalla Banca Vaticana.
Secondo Yallop, Luciani fu assassinato per volontà di Licio Gelli, con il supporto diretto o indiretto di:
- Michele Sindona e Roberto Calvi, che avevano buone ragioni per desiderarne la morte, nonché capacità e mezzi per organizzarla;
- Paul Marcinkus, indicato quale “regista” dell’intera operazione;
- John Patrick Cody, perché passibile di esonero dalla sede di Chicago per motivi legati ad una discutibile gestione finanziaria, di cui la corte federale iniziava ad interessarsi;
- Jean-Marie Villot, che avrebbe appoggiato e permesso il compimento dell’operazione.
Anche a seguito delle rivelazioni di Yallop, nel 1997 e negli anni seguenti, un gruppo di deputati e senatori italiani presentò in Parlamento alcuni atti di sindacato ispettivo (quali interrogazioni parlamentari, interpellanze ecc.) richiedendo delucidazioni in merito al misterioso decesso di Papa Luciani.
Secondo Yallop, erano due i temi scottanti sui quali Luciani era in contrasto con il gruppo di potere vaticano e gli ambienti massonici: questione demografica (controllo delle nascite) e gestione finanziaria.
Villot e pochissimi altri sapevano del dialogo in corso tra il nuovo Papa e il Dipartimento di Stato americano sulla questione demografica e dell’udienza privata che era stata fissata tra Papa Luciani e una delegazione di parlamentari americani, appunto per discutere il tema del controllo delle nascite. Le discussioni con Luciani avevano dissipato in Villot ogni dubbio sulle posizioni innovative del nuovo Papa su questo tema. Egli era certo che ci sarebbe stata una drastica inversione di marcia. Alcuni, come Villot e altri conservatori, ritenevano che questa svolta sarebbe stata un tradimento del pensiero di Paolo VI. Molti, invece, l’avrebbero acclamata come il maggior contributo della Chiesa al superamento del più drammatico tra i problemi del XX secolo.
Il nuovo Papa aveva deciso un generale repulisti degli uomini più vicini alla Banca Vaticana, lo IOR. E il 20 settembre 1978 era ormai chiaro che cinque uomini – Marcinkus, Villot, Cody, Sindona e Gelli – avevano moltissimo da temere se Giovanni Paolo I fosse vissuto e moltissimo da guadagnare se fosse morto improvvisamente.
Nel memoriale del pentito di Cosa Nostra Vincenzo Calcara sulle rivelazioni fatte a Paolo Borsellino, rese pubbliche a inizio 2008, Calcara racconta di essere venuto a conoscenza di una congiura di quattro cardinali (Jean-Marie Villot, Pasquale Macchi, Giovanni Benelli e un certo Gianvio), tutti membri, come Marcinkus, dell’Ordine del Santo Sepolcro e in diretto contatto con Antonio Albano (notaio personale di Giulio Andreotti, del boss Luciano Liggio e di Frank Coppola e «fiore all’occhiello» di Cosa Nostra) che, usando Marcinkus, uccisero il papa «con una gran quantità di gocce di calmante», «con l’aiuto del suo medico personale».
Alla base del gesto, sarebbe stata l’insofferenza di Papa Luciani verso «l’idea che cardinali e vescovi amministrassero tramite lo I.O.R. enormi ricchezze. La prima cosa che aveva già deciso di fare sarebbe stata quella di rimuovere alcuni cardinali che gestivano, usavano e manipolavano il vescovo Marcinkus sfruttando non solo la sua posizione all’interno dello I.O.R., ma anche e soprattutto i contatti e le potenti amicizie internazionali che il monsignore aveva».
L’idea “rivoluzionaria” di Luciani era di «distribuire il 90% delle ricchezze in diverse parti del mondo, costruendo case, scuole, ospedali etc., dopodiché il 10% dei restanti beni sarebbe stato affidato, per i bisogni della Chiesa, allo Stato italiano», progetto inaccettabile per i vertici delle finanze vaticane.
È inoltre documentato che una religiosa tedesca, suor Erika Holzach, già segretaria del professor Feiner, teologo e perito al Concilio, affermasse di essere stata scelta da Dio, negli ultimi anni della sua vita, per ricevere “visioni” riguardanti eventi ecclesiali importanti. Giovanni Paolo I sarebbe apparso più volte nelle visioni di Suor Erika.
La religiosa, scomparsa nel 1987, “vide” la morte di Papa Luciani, senza essere a conoscenza del libro di Yallop:
| « Vedevo Papa Luciani era presente, sicuro e reale… Ieri sera, quasi alla fine della preghiera… mi è stato dato di conoscere qualcosa in modo molto chiaro: nella notte in cui fu ucciso, due uomini entrarono nella stanza da letto del Papa. Il primo aveva una siringa, l’altro doveva solo fare la guardia. Ma il Santo Padre si è svegliato e ha capito subito che volevano ucciderlo. Ha visto anche il secondo uomo, non poteva e non voleva difendersi. Ha accettato volontariamente di morire per amore. Tutto è successo molto velocemente. La cara Madre di Dio mi ha rivelato che il Santo Padre si è consegnato totalmente nell’ultimo istante, raccomandando a Lei la Chiesa e il futuro Papa. » |
| (suor Erika Holzak) |
Il 5 settembre 1978, durante l’udienza privata concessa dal Papa al vescovo metropolita russo di Leningrado Nikodim, questi si accasciò in terra e spirò improvvisamente. Si ipotizzò che la morte di Nikodim, che si vociferava fosse al servizio del KGB, fosse avvenuta a causa dell’incauta ingestione di un caffè alterato, destinato a Papa Luciani probabilmente alterato da chi dopo, nella teoria cospiratoria, lo uccise, ossia la massoneria interna al Vaticano.
La Chiesa cattolica ha sempre respinto con forza ogni ipotesi dell’omicidio. Anche in ambienti laici, l’opera del giornalista inglese è stata bollata come poco attendibile, per il suo taglio più al limite del romanzo che dell’inchiesta giornalistica, per l’immagine distorta che mostra della personalità del pontefice e per alcune incongruenze fra le affermazioni in esso contenute e la realtà dei fatti.
Per le numerose persone vicine a Luciani, primo tra tutti il fratello Edoardo, ogni ipotesi di complotto è da liquidare come “sciocca e infondata“.
A tal proposito, è da ricordare che, per esempio, Papa Luciani respinse le dimissioni di Marcinkus, uno dei presunti cospiratori, nonostante l’operato di gestione delle finanze vaticane operata dal monsignore americano fosse ben lontano dall’idea di banca etica del pontefice bellunese.
L’insolita repentina scomparsa del pontefice da poco eletto si circondò d’aneddoti di tematica paranormale, tendenti ad accreditare l’esistenza d’una qualche premonizione o addirittura della consapevolezza della morte imminente da parte dello stesso Albino Luciani.
Una prima voce di questo tipo riguarda l’incontro con la religiosa Lucia dos Santos, nota come veggente di Fátima. La suora avrebbe predetto i due eventi (l’elezione al soglio pontificio e l’improvviso decesso) allo stesso cardinal Luciani nel 1977. L’episodio è però screditato da fonti ecclesiastiche.
Altro noto richiamo al destino di papa Luciani è stato letto nella celebre profezia di Malachia, dalla quale risulterebbe assegnato a Giovanni Paolo I il motto De medietate Lunae (che potrebbe essere interpretato come «Il tempo medio d’una luna»). V’è stato visto un riferimento alla durata del pontificato (33 giorni), vagamente paragonabile a quella d’una fase lunare (29 giorni).
L’incontro con suor Lucia e il segreto di Fatima
Uno degli episodi più importanti nella vita di Papa Luciani sembra essere stato l’incontro con Suor Lucia. Il 10 luglio 1977, l’allora cardinale Luciani, molto devoto alla Madonna di Fatima, accogliendo l’invito di Suor Lucia, vi si recò in pellegrinaggio (esattamente a Cova da Iria) incontrando al Carmelo di Coimbra la famosa mistica, con la quale si trattenne per due ore in conversazione. Suor Lucia gli avrebbe rivelato il contenuto del Terzo Segreto (o, più correttamente, la III parte del Segreto o Messaggio) di Fatima. Egli ne fu sensibilmente impressionato e, una volta rientrato in Italia, descrisse così quell’incontro: “La suora è piccolina, è vispa, e abbastanza chiacchierina… parlando, rivela grande sensibilità per tutto quel che riguarda la Chiesa d’oggi con i suoi problemi acuti…; la piccola monaca insisteva con me sulla necessità di avere oggi cristiani e specialmente seminaristi, novizi e novizie, decisi sul serio ad essere di Dio, senza riserve. Con tanta energia e convinzione m’ha parlato di suore, preti e cristiani dalla testa ferma. Radicale come i santi: ou todo ou nada: o tutto o niente, se si vuol essere di Dio sul serio”.
Si dice anche che suor Lucia abbia predetto a Luciani la sua elezione e il breve pontificato, chiamandolo “Santo Padre” tuttavia nel 2006 il Segretario di Stato Vaticano Tarcisio Bertone ha definito questa storia “tesi vecchia e priva di fondamento”. A tal proposito, si ricorda che il fratello Edoardo vide il cardinale Luciani tornare molto scosso dal viaggio a Fatima: era diventato silenzioso e spesso assorto nei pensieri e quando gli chiese cosa avesse, Albino rispose: “Penso sempre a quello che ha detto Suor Lucia”.
Il ricordo di Papa Ratzinger
Vale la pena ricordare, infine, le parole di Papa Ratzinger dedicate a Giovanni Paolo I:
« Riflettendo su questi testi biblici, ho pensato subito a Papa Giovanni Paolo I, di cui proprio oggi ricorre il trentesimo anniversario della morte. Egli scelse come motto episcopale lo stesso di san Carlo Borromeo: Humilitas. Una sola parola che sintetizza l’essenziale della vita cristiana e indica l’indispensabile virtù di chi, nella Chiesa, è chiamato al servizio dell’autorità. In una delle quattro Udienze generali tenute durante il suo brevissimo pontificato disse tra l’altro, con quel tono familiare che lo contraddistingueva: “Mi limito a raccomandare una virtù, tanto cara al Signore: ha detto: imparate da me che sono mite e umile di cuore … Anche se avete fatto delle grandi cose, dite: siamo servi inutili”. E osservò: “Invece la tendenza, in noi tutti, è piuttosto al contrario: mettersi in mostra” (Insegnamenti di Giovanni Paolo I, p. 51-52). L’umiltà può essere considerata il suo testamento spirituale.
Grazie proprio a questa sua virtù, bastarono 33 giorni perché Papa Luciani entrasse nel cuore della gente. Nei discorsi usava esempi tratti da fatti di vita concreta, dai suoi ricordi di famiglia e dalla saggezza popolare. La sua semplicità era veicolo di un insegnamento solido e ricco, che, grazie al dono di una memoria eccezionale e di una vasta cultura, egli impreziosiva con numerose citazioni di scrittori ecclesiastici e profani. È stato così un impareggiabile catechista, sulle orme di san Pio X, suo conterraneo e predecessore prima sulla cattedra di san Marco e poi su quella di san Pietro. “Dobbiamo sentirci piccoli davanti a Dio”, disse in quella medesima Udienza. E aggiunse: “Non mi vergogno di sentirmi come un bambino davanti alla mamma: si crede alla mamma, io credo al Signore, a quello che Egli mi ha rivelato” (ivi, p. 49). Queste parole mostrano tutto lo spessore della sua fede. Mentre ringraziamo Dio per averlo donato alla Chiesa e al mondo, facciamo tesoro del suo esempio, impegnandoci a coltivare la sua stessa umiltà, che lo rese capace di parlare a tutti, specialmente ai piccoli e ai cosiddetti lontani. Invochiamo per questo Maria Santissima, umile Serva del Signore. »
(Benedetto XVI, Angelus, Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo, 28 settembre 2008)
—
Bibliografia
- John Cornwell, Un ladro nella notte. La morte di papa Giovanni Paolo I. Pironti Editore, Napoli, 1990
- Lucio D’Orazi, In nome di Dio o del diavolo. Edizioni Logos, Roma, 1988
- Luigi Incitti, Papa Luciani: una morte sospetta. L’Airone Editrice, Roma, 2001
- Jesus Lopez Saez, Se pedira cuenta. Muerte y figura di Juan Pablo I. Edizioni Origenes, Madrid, 1990
- Albino Luciani, Un vescovo al Concilio – Lettere dal Vaticano II. Città Nuova, Roma, 1983.
- Max Morgan-Witts e Thomas Gordon, Dentro il Vaticano. Storia segreta del pontificato di Giovanni Montini, Albino Luciani e Karol Wojtyla. Pironti Editore, Napoli, 1989 e 1995
- David Yallop, In nome di Dio. Pironti Editore, Napoli, 1985 e 1992
- Giancarlo Zizola, Il conclave. Storia e segreti. Compton Editori, Roma, 1993
Categorie:I20.02 - Storia della Chiesa cattolica - History of the Catholic Church
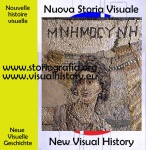

Lascia un commento