La matematica metaforica di Cusano
Nicola Cusano, anche noto come Niccolò Cusano o Niccolò da Cusa (1401 – 1464) ritiene che la conoscenza umana si modelli sulla conoscenza matematica. Nell’ambito della conoscenza noi conosciamo ciò che è ignoto solo se esso ha una proporzionalità con ciò che è già noto. Quindi, per Cusano, la conoscenza si basa sull’omogeneità tra noto ed ignoto come in matematica: tanto più le verità sono vicine a ciò che già conosciamo, tanto più facilmente le conosciamo. Di fronte a ciò che non è assolutamente omogeneo a quanto conosciamo noi non possiamo che proclamare la nostra ignoranza, la quale sarà però una “dotta ignoranza” in quanto ne siamo consapevoli.
L’infinito è ignoto
Il filosofo tedesco si serve spesso di esempi e di metafore di tipo matematico o geometrico per spiegare i suoi concetti filosofici. Per esempio, il rapporto che intercorre tra il limitato intelletto umano e il concetto di Dio può essere meglio compreso visualizzando il rapporto tra una circonferenza (Dio) e a un poligono inscritto alla circonferenza (l’intelletto umano), i lati del quale possono essere indefinitamente aumentati di numero, senza che mai il poligono raggiunga la circonferenza in tutti i suoi punti. Il concetto di dotta ignoranza ha appunto lo scopo di spiegare, mediante una paradossale metafora, come l’avvicinamento a Dio della limitata mente umana sia sempre sostanzialmente insufficiente.
La verità non è né un più né un meno, consiste in qualcosa di indivisibile e non può con precisione misurarla tutto ciò che esiste come diverso dal vero: così come il circolo, il cui essere consiste in qualcosa di indivisibile, non può misurare il non-circolo. L’intelletto, dunque, che non è la verità, non comprende mai la verità in modo così preciso da non poterla comprendere più precisamente ancora all’infinito, perché sta alla verità come il poligono sta al cerchio.
La “visio intellectualis”
Il filosofo e storico della filosofia Ernst Cassirer sostiene che con il legame posto tra ricerca matematica e teologia, in modo nuovo e originale rispetto alla tradizione, Nicola Cusano si pone all’inizio del pensiero moderno. Dopo aver letto il brano che segue svolgine un riassunto entro i limiti dello spazio assegnato.
Il Cusano, per mostrare il senso e lo scopo della «visio intellectualis», non si richiama tanto alla forma mistica della contemplazione passiva, quanto, piuttosto, alla matematica. Essa diventa per lui l’appropriato, unico vero e “preciso” simbolo del pensiero speculativo e della visione speculativa che ricollega le opposizioni. «Nihil certi habemus in nostra scientia nisi nostram mathematicam»: dove vien meno il linguaggio della matematica, là, per lo spirito umano, non vi è più nulla di concepibile né di conoscibile. (E. Cassirer, Individuo e cosmo nella filosofia del Rinascimento)
I testi di Cusano si pongono come una sorta di spartiacque tra filosofia medievale e moderna. Da un lato si nota infatti l’utilizzo di una terminologia ancora medioevale, ma dall’altro emergono temi e motivi sviluppati secondo modalità del tutto nuove, come emerge per esempio dalla lettura del rapporto tra finito e infinito, dalla concezione matematica del mondo e di Dio, dal rapporto tra la singolarità degli enti e il loro fondamento in Dio, temi tutti che torneranno incessantemente nella filosofia dei secoli successivi.
Infatti essendo risultato evidente nel primo libro che Dio è in tutte le cose, perché tutte le cose sono in lui, ed essendo ora chiaro che Dio in un certo senso è in tutte le cose per la mediazione dell’universo, ne deriva da ciò che tutto è in tutto e che qualsivoglia cosa è in qualsivoglia cosa. Infatti l’universo, quasi per legge di natura, ha preceduto, in quanto perfettissimo, tutte le cose, appunto affinché qualsivoglia cosa fosse in qualsivoglia cosa.
[…]
Non è altra cosa, dunque, affermare che qualsivoglia cosa è in qualsivoglia cosa che l’affermare che: Dio attraverso il tutto è in tutto, e tutte le singole cose attraverso il tutto sono in Dio (N. Cusano, De docta ignorantia, I, 5).
Il termine tutto, nel senso in cui è utilizzato da Cusano, esprime una concetto che — secondo la concezione della teologia negativa e della dotta ignoranza — non può essere concepito in termini compiuti e chiari. Comprende infatti Dio, l’unità che è al di là di ogni molteplicità. Il rapporto tra finito e infinito, cioè tra la singolarità di ciascun ente e il suo fondamento in Dio, è quindi letto nella chiave del rapporto tra complicatio ed explicatio, come è qui segnalato dall’uso del termine «contratto».
L’dea di massimo e di minimo
Siamo di fronte a uno degli aspetti piú significativi della filosofia di Cusano: il tentativo di comprendere la possibilità di una coincidentia oppositorum quando il pensiero si rivolge a concetti-limite quali l’idea di massimo e l’idea di minimo. Questa coincidentia oppositorum, pur risultando in parte comprensibile se riferita al piano delle quantità, rimane comunque “trascendente le capacità del nostro intelletto”.
Il massimo, del quale nulla può essere piú grande, essendo in modo semplice ed assoluto piú grande di quel che da noi si possa capire, poiché è verità infinita, noi non lo cogliamo altrimenti che in modo incomprensibile. Non essendo infatti esso della natura di quelle cose che ammettono un termine che supera ed uno che sia superato, esso è al di sopra di tutto ciò che da noi può essere concepito […].
È evidente che il minimo coincide con il massimo. E ciò ti sarà piú chiaro se ricondurrai il massimo ed il minimo nell’ambito della quantità. La massima quantità è infatti massimamente grande; la quantità minima è massimamente piccola. Libera dunque dalla quantità massimo e minimo, sottraendo intellettualmente l’esser grande e l’esser piccolo, e chiaramente vedrai che massimo e minimo coincidono. Cosí infatti è un superlativo il massimo come lo è il minimo. L’assoluta quantità pertanto non è piú massima che minima, poiché in essa coincidono massimo e minimo.N. Cusano, De docta ignorantia, I, cap. IV
Ernst Cassirer ha messo in evidenza il rapporto complesso fra teologia e matematica che prende corpo nella filosofia di Cusano.
Il Cusano si riallaccia alla filosofia greca, al suo sviluppo dell’opposizione tra l’“uno” e i “molti” […] e affronta il problema in questi termini [nei termini dialettici proposti da Platone]; il suo sguardo indugia soprattutto sulla difficoltà insita nel concetto di Trinità, dell’unità delle tre persone divine. Proprio questo costituisce il suo interno legame con il Medioevo e particolarmente con Anselmo d’Aosta e Giovanni Scoto Eriugena. Ma, quanto piú profondamente egli si addentra nel dogma della trinità, tanto piú è spinto a comprendere e a spiegare il rapporto che esiste, nella nostra coscienza, tra l’intelletto, l’oggetto intelligibile e la loro unità nell’atto della conoscenza. Cosí il contenuto, che dalla filosofia greca era passato alla teologia, ritrova la sua autonomia. Il Cusano, superando i limiti della formulazione teologica, ritorna al problema universalmente valido del “Lógos in noi stessi” e alla considerazione della sua particolare natura eterna.(E. Cassirer, Storia della filosofia moderna, vol. I, Einaudi, Torino, 1964, pagg. 68-77)
L’interessamento all’astronomia
Nel 1444 Cusanosi era appassionato all’astronomia e si dedicò dunque al suo studio insieme a Georg von Peuerbach. Conobbe in questo periodo Regiomontano, in quanto collaborava con Peurbach e così conobbe gli scritti di Cusano che sostenevano la visione eliocentrica dell’Universo; per questo ebbe un dibattito con il cardinale Cusano poiché rimase tuttavia un geocentrico, seguace di Tolomeo. Cusano sostenne, contro Tolomeo e Aristotele, che la Terra non è immobile, ma ruota intorno al proprio asse e che non è possibile determinare il centro dell’universo, che è infinito; che le stelle sono simili al Sole, che intorno ad esse possono ruotare dei pianeti e che alcuni pianeti possono essere abitati; produsse quindi delle teorie molto simili a quelle dell’astronomia a noi contemporanea. Si tratta, in effetti, di una visione dell’universo che appartiene alla tradizione neoplatonica e che è stata sostenuta anche nel Medio Evo, dai testi di Ermete Trismegisto ad Alano di Lilla (XII secolo). Cusano si occupò inoltre di una possibile riforma del calendario e apportò miglioramenti alle Tavole alfonsine. Oltre a Giordano Bruno (per via della teoria cusaniana sulla cosmologia), presero spunto da lui anche Agrippa von Nettesheim, Charles de Bovelles, Erasmo da Rotterdam, Leonardo da Vinci, Niccolò Copernico, Giovanni Keplero, Galileo Galilei, Gottfried Leibniz, Georg Hegel, Carl Friedrich Gauss, Friedrich Schelling e Albert Einstein.
Categorie:K30.01- Filosofia e matematica - Philosophy and Mathematics
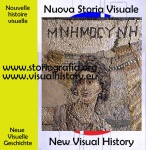
Lascia un commento